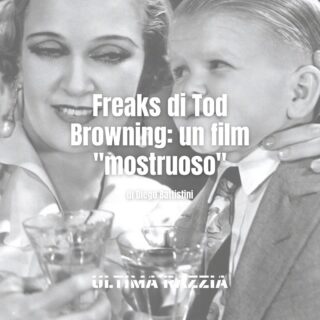Tra il 1948 (Ladri di biciclette di Vittorio De Sica) e il 1950 (Bellissima di Luchino Visconti) l’esperienza del Neorealismo si esaurisce. Il motivo non è rintracciabile esclusivamente nell’ostilità della classe politica, bensì nell’essiccazione delle radici vitali che l’avevano determinata: la Resistenza, i suoi valori, la speranza di realizzarli. Già nel 1948 con Germania anno zero, Roberto Rossellini compì un primo significativo allontanamento dall’estetica neorealista. I palazzi sventrati della Berlino postbellica non erano più mere rovine, come quelle mostrate un paio di anni prima in Paisà (1946), ma rappresentazione/proiezione dell’animo lacerato del giovane Edmund, vittima innocente della follia umana. Un distacco dal realismo (nell’accezione più ristretta del termine), quello rosselliniano, per certi già in nuce nelle sue opere precedenti (a cominciare da Roma città aperta, 1945). Diverso è invece il caso di Vittorio De Sica, l’autore più rigorosamente fedele al Neorealismo. Nel 1951, quando il Dopoguerra sta lentamente cedendo il passo all’epoca del Boom economico, De Sica, insieme al fido sceneggiatore (o sarebbe il caso di definirlo co-autore a tutti gli effetti?) Cesare Zavattini, porta al cinema un’opera singolare e in controtendenza rispetto alle sue precedenti: Miracolo a Milano.

Il realismo lascia spazio agli archetipi della fiaba. La poetica di Zavattini (autore anche del libro da cui è tratto il film, Totò il buono) sembra avere la meglio sulla rigorosa fedeltà al Neorealismo del regista. Non è un successo, tutt’altro. La critica prende le distanze: ai due autori non viene perdonato il fatto di aver abbandonato l’impegno etico, politico e sociale. È chiaramente un abbaglio. Nonostante la sua estetica sia effettivamente antitetica rispetto a quella puramente neorealista, Miracolo a Milano è una delle disamine più lucide di un Paese che sta attraversando gli anni più difficili del Dopoguerra, caratterizzati dalla volontà di lasciarsi l’esperienza bellica alle spalle e ricominciare a vivere. Un’Italia alla ricerca di una sofferta normalità.
C’era una volta nell’Italia del Dopoguerra
Come tutte le fiabe che si rispettino anche Miracolo a Milano inizia con il fantomatico incipit «C’era una volta…». In questo caso, però, non siamo al cospetto di un fantomatico reame, bensì dei sobborghi contadini di una Milano in espansione, dove i confini tra campagna e città sono ancora molto labili. Proprio in questa “periferia bucolica” l’anziana Lolotta (Emma Grammatica) trova, sotto un cavolo, un neonato, Totò. Basterebbe la sorprendente sequenza iniziale del film per testimoniare l’interesse di regista e sceneggiatore a recuperare l’eredità strapaesana delle credenze popolari. Ben presto, però, la campagna lascia spazio alla più neorealista città. A seguito della morte di Lolotta, infatti, il piccolo Totò è costretto ad affacciarsi alla vita e alle sue mille contraddizioni. Viene “accolto” in orfanotrofio, e poi, una volta uscito, ormai adulto (Francesco Golisano, ex dipendente delle Poste e attore non professionista, già protagonista di Sotto il sole di Roma di Renato Castellani, 1948), è costretto a vedersela da solo. E qui cominciano i problemi. Perché Totò, come suggerisce anche il titolo del romanzo di Zavattini dal quale trae ispirazione il film, è un buono, un puro di cuore, un ingenuo (nell’accezione positiva del termine).

Non a caso, il primo impatto con la realtà che lo circonda è traumatico; anche se lui, a dire il vero, non sembra subirne più di tanto le conseguenze, sorretto com’è da un ottimismo contagioso. Dapprima si prende del «bamba» (in italiano: stupido) da un impiegato che sta andando a lavoro solo perché ha avuto l’ardire di salutarlo con un «Buongiorno», poi si lascia rubare la valigia dall’inadempiente Alfredo (Arturo Bragaglia), che poi diverrà suo amico e lo inviterà a passare la notte nella sua “abitazione”: una capanna di cartone edificata in una baraccopoli incastonata tra la città e la ferrovia. È proprio l’introduzione di questo spazio partorito dalla miseria ad aprire uno squarcio sulla realtà dell’Italia del Dopoguerra. Una rappresentazione drammatica, quella della povertà, che il film acuisce attraverso il parallelismo con una società già influenzata dai primi sentori della ripresa economica, dove il consumismo comincia a fagocitare non solo lo spazio urbano – si pensi alla pubblicità delle Scarpe Fate («Camminate felici») in cui si imbatte Totò mentre, solo, segue a piedi il carro funebre che trasporta per l’ultima volta la compianta Lolotta -, ma anche i sogni di coloro che quello spazio lo abitano (siano essi benestanti o meno). Questa cruda raffigurazione della realtà è però contraddistinta, come già accennato, da elementi favolistici che sembrano anticipare persino il cinema onirico di Federico Fellini, e che – paradossalmente – non stemperano la tragedia, bensì l’accentuano.

Miracolo a Milano non è comunque il primo film di De Sica e Zavattini in cui i due autori si affidano ad elementi tipici della fiaba. Già in Sciuscià (1946) la figura diafana del cavallo che i due giovani lustrascarpe comprano con i soldi guadagnati per le strade di Roma è una significativa deviazione dalla realtà, fungendo da emblema di un impossibile ritorno – per i due giovani protagonisti – a una dimensione infantile. In Miracolo a Milano, però, si rintraccia un’inversione nelle gerarchie. Non è più il registro (neo)realista a primeggiare su quello fantastico, ma il contrario. All’epoca della sua uscita ciò venne ritenuto oltraggioso dalla critica, e nessun si accorse della felice intuizione di De Sica e Zavattini: utilizzare gli stilemi tipici della satira, una forma di racconto all’apparenza più leggera ma in verità tra le più efficaci per vivisezionare la complessità del reale.
Una digressione satirica
Oggi sappiamo che Miracolo a Milano non rappresentò una vera e propria svolta per il cinema di De Sica e Zavattini. Il distacco dal Neorealismo fu provvisorio, e già l’anno successivo Umberto D. (1952) ricondusse i due autori nell’alveo del movimento (che poi fu più che altro una convergenza di pensieri dettato da una contingenza storica). Eppure, la storia di Totò non può essere accomunata a un sottogenere qual è il Neorealismo rosa. In fondo, che cosa ha in comune Miracolo a Milano con film coevi quali Pane, amore e fantasia (1953) di Luigi Comencini o Due soldi di speranza (1952) di Renato Castellani? Nulla. Così come parallelismi non si possono rintracciare con altri autori capaci di andare oltre il Neorealismo come il “calligrafico” Mario Soldati (Fuga in Francia, 1948), il brechtiano Giuseppe De Santis (Non c’è pace tra gli ulivi, 1950) e l’alfiere del cinema di genere Pietro Germi (Il cammino della speranza, 1950). No, Miracolo a Milano è un film estraneo al panorama del cinema italiano di quegli anni; una scheggia aliena profondamente radicata nella contemporaneità (che racconta con tragica ironia) e, al contempo, precorritrice di una comicità acre tendente al demenziale che avrà fortuna nell’industria cinematografica del Bel Paese più di vent’anni dopo.

Stupisce, da questo punto di vista, ritrovare nel film di De Sica e Zavattini espedienti narrativi che saranno poi utilizzati dal Fantozzi (1975) di Luciano Salce. Gli esempi sono molteplici: l’immagine di una società schiava del Capitale, la rappresentazione mefistofelica del Padrone (da una parte il signor Mobbi, dall’altra il Mega Direttore Galattico), il dipendente utilizzato come barometro vivente che anticipa il ragioniere parafulmine, la battaglia tra i poveri e gli “squadristi” di Mobbi con l’utilizzo persino di carri armati, che ricorda la celebre scena della caccia in Il secondo tragico Fantozzi (1976), sempre di Salce.
Come nel caso dei film con protagonista Paolo Villaggio, anche in quello di De Sica e Zavattini si ride, ma dietro l’ironia risiede sempre il dramma di un paese che nonostante l’imminente ricostruzione vede allargarsi irrimediabilmente la forbice tra ricchi e poveri. Una nazione proiettata verso il futuro che non ha più alcuna intenzione di voltarsi indietro, dove la povertà non è più una condizione accettabile, anzi è un panno sporco che si dovrebbe lavare in casa e non mostrare con orgoglio su uno schermo cinematografico (ogni riferimento alla celebre battuta proferita da Giulio Andreotti in riferimento all’uscita di Umberto D. non è casuale). E non è un caso che, alla fine del film, l’impasse dello scontro tra gli indigenti che chiedono solo un posto dove stare («Ci basta una capanna, per vivere e dormire», cantano) e i capitalisti guidati dal profitto è spezzata solo dal ricorso a un classico Deus ex Machina: l’intervento divino di Lolotta che dona a Totò una colomba magica grazie alla quale il giovane riesce a respingere le offensive degli uomini di Mobbi e a far virare il film verso un fine lieto che nasconde però più di un’ambiguità.
Oltre il Neorealismo
La sequenza finale di Miracolo a Milano è una delle più celebri del cinema italiano del secondo Dopoguerra. I poveri, tra i quali Totò, si disperdono lungo le vie di Milano e, giunti in Piazza del Duomo, rubano le scope dei netturbini impegnati a pulire le strade cavalcandole sopra i cieli della plumbea città e dirigendosi – come dice la scritta in sovrimpressione – verso un avvenire dove buongiorno vuol dire veramente buongiorno. Tutto è bene quello che finisce bene, verrebbe da dire; ma è davvero così?

In realtà, il finale del film di De Sica e Zavattini è assai più problematico e soprattutto grave rispetto alle apparenze. Molti critici nel corso degli anni hanno avanzato le ipotesi più suggestive sul significato di tale sequenza conclusiva: da un lato, il volo delle scope verso “l’avvenire” è stato interpretato come un messaggio mortifero, dall’altro – in senso più positivo e politico – come una dichiarazione d’amore di regista e sceneggiatore nei confronti del socialismo sovietico. Evitando di fare voli pindarici e limitandoci al rapporto che il film instaura con il Neorealismo, verrebbe da dire che la conclusione di Miracolo a Milano non è meno disperata rispetto a quelle più “accomodanti” di Ladri di biciclette e Umberto D., e a quella più tragica di Sciuscià. La fuga dei poveri verso un mondo migliore ha, infatti, una doppia valenza. A livello squisitamente narrativo è un escamotage utilizzato per concludere il film con un’immagine sorprendentemente lieta; a un livello più profondo, invece, il colpo di scena mette in evidenza l’inattualità della condizione di indigenza. Se ancora nel 1948 la povertà era una condizione “naturale” per gli italiani usciti dalla guerra, scavallati gli anni ’50, tale condizione diviene, più che una piaga sociale, una colpa di fronte a una società che vuole lasciarsi il passato alle spalle. Se, come diceva André Bazin, Ladri di biciclette era un film che mostrava una realtà in cui i poveri erano costretti a derubarsi tra loro per sopravvivere, Miracolo a Milano descrive un mondo dove per i poveri, banalmente, non c’è ormai più posto.

Se letto da questo prospettiva, il film comincia ad assumere una dimensione diversa all’interno della filmografia di De Sica e Zavattini. A ben vedere, infatti, il successivo Umberto D. porta avanti la medesima riflessione, anche se lo fa rientrando apparentemente nell’alveo del Neorealismo, nonostante le contaminazioni espressioniste (le stesse che avevano già influenzato il realismo rosselliniano in Germania anno zero). E non stupisce che all’epoca Miracolo a Milano non sia stato apprezzato né dalle forze politiche di Destra (il presunto riferimento al Comunismo), né da quelle di Sinistra, che criticarono De Sica e Zavattini di aver offerto una visione edulcorata della realtà, non capendo (entrambe le parti) che in quella rappresentazione favolistica si celavano “solamente” le tragiche contraddizioni della modernità.
Leggi anche: La Ciociara, una carta d’identità della Storia italiana
Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in anteprima tutti gli articoli di Ultima Razzia!
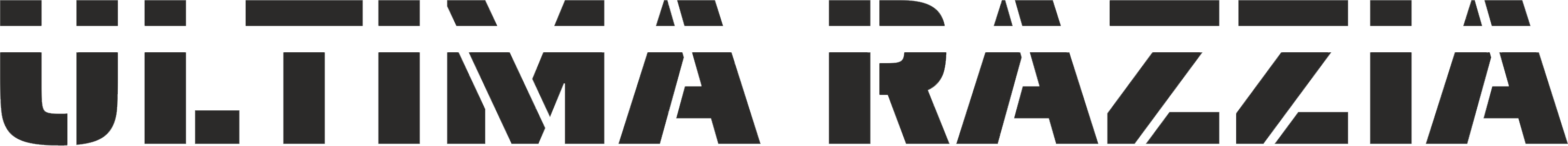



 Loading...
Loading...