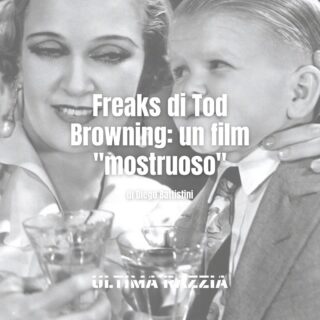È da poco uscito nelle sale italiane Fortuna, esordio di Nicolangelo Gelormini nel lungometraggio con una storia ispirata dai tragici fatti della piccola Fortuna Loffredo, vittima di abusi nel 2014. Valeria Golino, Pina Turco e la giovanissima Cristina Magnotti sono le tre protagoniste di un film intenso, coraggioso e stratificato. Tra architetture vive al pari dei personaggi e tematiche cupe come la notte, Gelormini si muove con l’eleganza della trasfigurazione in uno spazio strutturato secondo canoni rigorosi e poetici. Abbiamo pensato che l’intervista radiofonica di qualche settimana fa non fosse abbastanza, e l’abbiamo ricontattato per una lunga chiacchierata.
Nicolangelo, ti sei laureato in Architettura con un film sulla chiesa di Santa Maria dello Spasimo di Palermo, un luogo che ricorda l’estetica dell’abbazia di san Galgano, una delle location dove Tarkovskij ha girato alcune celeberrime scene di Nostalghia. C’è già in questa scelta una sorta di afflato se non proprio religioso, quantomeno spirituale o “metafisico” nella tua idea di arte e di cinema? Una spinta all’”oltre”, riscontrabile anche in Fortuna?
Lo Spasimo è un luogo magico, è un posto che è stato usato anche da artisti del calibro di Battiato e di Vanessa Beecroft. Non so se definirei proprio religiosa la mia idea di cinema. Sai cosa credo? Se tu pensi alla sala cinematografica non è tanto diversa da una chiesa. Nel senso che l’elemento liturgico bene o male è lo stesso. C’è un pubblico e un altare, che nel caso del cinema è uno schermo. Con le dovute distanze, il tempio greco, la chiesa, il cinema, il teatro, sono tutte forme di condivisione verso un altrove, un Altro. Verso qualcosa che sta fuori di noi ma che racconta qualcosa che è dentro di noi. Quindi siamo comunque di fronte a un elemento sovrumano in questo senso: è fuori dall’essere umano ciò verso cui tu ti poni, ma che da un senso a qualcosa che è dentro di te. In questo senso probabilmente si. Però poi in ogni ambito artistico esiste una specifica forma di spiritualità.

I registi, gli artisti di qualsiasi campo che ti hanno influenzato di più?
Non saprei, è una domanda alla quale non so mai rispondere. Ognuno si forma e si informa su tantissime cose. Ovviamente ci sono delle tracce che lasciano più il segno rispetto ad altre. Però secondo me è anche giusto che un autore, un regista, un artista in generale non sia troppo consapevole della propria matrice. Tu ti metti su un flusso, su un sentiero battuto da tanti maestri che hanno fatto la storia e che ti influenzano. Provi a metterti in quel solco lì, con la massima accortezza e il massimo tatto. Ma non saprei decodificare quali sono gli elementi che poi hanno caratterizzato la mia calligrafia. Io ogni tanto parlo di scrittura intesa anche come scrittura per immagini. Penso che noi siamo il frutto di tantissime cose, ma siamo anche il frutto di un momento storico della nostra vita, per cui quando giri un film sei pervaso da mille cose proprio in quell’hic et nunc lì. Poi magari domani giri un’altra cosa e la giri in maniera completamente diversa. Soprattutto ora che è tutto molto più rapido siamo molto più sollecitati, rispetto magari a prima dell’avvento di internet. Oggi possiamo andare a reperire davvero tantissime informazioni, input, suggestioni. Siamo sollecitati molto di più e quindi il lavoro di decodifica diventa ancor più difficile. E poi è una cosa che io non faccio: cioè, evito di farlo perché non ho questo tipo di carattere, mi rivolgo semplicemente a me e faccio più auto-analisi, piuttosto che analisi del testo.
Poco più che ventenne hai fatto l’assistente alla regia di Paolo Sorrentino per L’uomo in più. Eri giovanissimo: come sei arrivato sul set? Che esperienza è stata?
In realtà ho fatto anche l’aiuto regia su un corto che lui aveva realizzato sempre nel 2001, La notte lunga. Ero giovane anagraficamente, ma ero molto giovane anche a livello mentale, nel senso che ero proprio nuovo al cinema. Sapevo che volevo farlo, avevo questa spinta. Tutte le persone che finiscono per fare cinema si muovono perché hanno questa spinta molto forte. Ma all’inizio ti lanci comunque in un vuoto, perché io, ad esempio, non avevo proprio idea delle regole del mondo cinematografico. Ho fatto un vero e proprio salto nel buio, dicendomi: «Vediamo se il cinema è il contesto mio». Questo passaggio si fa da un lato per vocazione, ma poi dall’altro occorre capire anche se quel mondo ti sposa, se si tratta di un ambiente al quale reagisci naturalmente e al quale ti senti appartenere. Non ricordo benissimo come finii su L’uomo in più. Ricordo che andai a Napoli e attraverso degli amici cercai delle esperienze sui set, finendo per conoscere Paolo. In lui, che ritengo uno dei più grandi maestri al mondo, c’era già quello che c’è oggi. Quindi per me fu un’esperienza molto forte, proprio perché iniziavo la mia prima esperienza cinematografica con una personalità del genere. Fu un’esperienza che lì per lì non credo compresi fino in fondo. All’epoca ero terrorizzato: questo lo ricordo. Avevo paura di sbagliare, non volevo assolutamente commettere errori, quindi ero super teso e super attento per tutto il tempo che ho lavorato con lui. Cercavo di dare il massimo, ma non so quanto ho fatto bene. Ora, a distanza di vent’anni, mi rendo conto che ho assorbito molto: io l’imprinting l’ho avuto lì. Come si sta sul set, quali sono le maestranze, come lavorano, le responsabilità del regista…
Quindi hai imparato molto sul campo, più che dalla teoria.
In realtà ho fatto un po’ di tutto, perché dopo le esperienze sui set mi sono iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia. Quest’esperienza mi ha completato dal punto di vista teorico, e così facendo ho voluto anche un po’ assecondare il mio carattere. Sin da piccolo ho sempre avuto molta paura di commettere errori, quindi mi sono mosso sempre con grande attenzione e ho sempre cercato di arrivare pronto alle situazioni. Tutto quello che mi può essere utile per la formazione cerco di farlo. Mi sono così costruito una gavetta anche un po’ lunga, rispetto alla media.
Un’altra esperienza di campo è stata quella dei videoclip musicali. Dato che ti sei cimentato in molti ambiti, non ultimo il tuo primo lungometraggio, quale credi sia il linguaggio più confacente a te? Ne prediligi qualcuno?
Sono piani diversi. L’ambizione è quella di fare cinema. E per “fare cinema” io intendo arrivare a quella rappresentazione da grande sala che coinvolge e al tempo stesso sconvolge il pubblico. La mia è un’ambizione alta, e non so se l’ho realizzata già con la mia opera prima. Però il cinema è ciò verso il quale io tendo. Poi ovviamente il mondo dell’espressione visiva è fatta di tantissimi ambiti e ognuno ha il suo linguaggio. Allora si fanno film per la televisione, film per lo streaming, i videoclip, le pubblicità, i contributi video per i social, gli storytelling. E poi c’è quella cosa lì da tempio sacro: il cinema. Per me va bene tutto, ogni forma ha la sua legittimità. L’importante è dare il giusto nome alle cose e sapere cosa si va a fare. Quello che non gradisco è la confusione tra queste forme espressive, cioè quando si parla di cinema o di film impropriamente. Io sono tra quelli che cercano di dare la giusta definizione delle cose, ma semplicemente perché le parole sono importanti, come qualcun’alto ha detto prima di me. Ed è vero, non solo al cinema ma nella vita di tutti i giorni: la parola giusta, usata correttamente, ci consente di vivere bene, di vivere meglio. Consente anche una forma di rispetto, una cosa alla quale credo e tengo molto. Rispetto per quello che ci è attorno e per chi ci è attorno. Ecco, io questo uso della parola giusta la applico a tutto. Detto questo a me piace spaziare: mi piacerebbe fare una serie, mi piace fare la pubblicità, mi è piaciuto fare i videoclip. Sono tutte esperienze che mi piacciono perché l’espressione visiva è quella nella quale io penso di potermi esprimere al meglio, e te lo dice uno che è balbuziente. Nella mia esperienza il cinema è diventato anche un escamotage, per cercare di esprimermi meglio. Forse ogni regista ha questa voglia di farsi comprendere. O almeno: funziona così per me.

Parliamo di composizione delle immagini e di simmetria, elementi molto importanti nella tua poetica e dei quali forse ti hanno chiesto perfino in troppi. Eppure è davvero sorprendente notare quanto questa tendenza sia riscontrabile in molti dei tuoi lavori, è come se i tuoi edifici avessero vita propria, avessero una volontà interna che tu riporti alla luce. Lo si nota benissimo in una delle tue opere che preferisco, La casa del fascio, che mi ha colpito particolarmente.
È un’opera che ha tanto di cinematografico. E nulla di politico, ovviamente. Si: io credo nell’architettura. Ci credo in senso filosofico e ontologico. Credo che l’architettura sia materia animata e viva. L’architettura condiziona la vita degli esseri umani, il loro modo di stare al mondo, il loro carattere, il loro umore. Condiziona il movimento della luce, che entra ed esce da te, dai tuoi occhi, dalle tue cellule. E quindi per me usare l’architettura come un elemento vivo significa renderlo un personaggio della storia. Credo fermamente in tutto questo e sono contento che traspaia. L’architettura è un elemento in più che mi aiuta nella narrazione, per contrastare i miei personaggi umani o per assecondarli, per ingabbiare le loro emozioni o per farle esplodere. Il cinema è racconto per immagini, e l’architettura è essa stessa un’immagine, oltre che un luogo.
Esattamente come in Fortuna, del resto, dove si vedono nitidamente le sagome minacciose dei palazzi che a tratti sembrano inghiottire i personaggi, o minacciarli.
Si. Mi piaceva questa pesantezza per raccontare il punto di vista di una bambina in relazione a un mondo a un tempo adulto e costruito, che la schiaccia e la opprime. Nelle scene in questione quelle immagini che gravano sul capo della piccola Fortuna mi servivano non solo per la caratterizzazione del personaggio, ma anche per raccontare di quella situazione di sofferenza. Mi rendo conto di come ho utilizzato la mia architettura anche a posteriori, perché magari durante le riprese non l’ho nemmeno fatto a livello del tutto razionale. Ad esempio, ho visto che spesso ho ripreso elementi architettonici e li ho piazzati al centro del quadro per spaccare l’inquadratura in due. E mi rendo conto che ero come guidato dal tema del film, che parla di tradimento ma che porta con sé pure il tema del doppio. E quindi la sceneggiatura in due atti, i personaggi che si sdoppiano e che sono uno il contrappunto dell’altro… tante inquadrature risultano così divise in due, attraverso l’uso dell’architettura, che scelgo sempre con moltissima attenzione.
Sei tu che vai alla ricerca di determinati luoghi per ambientarvi una storia che hai in testa? Oppure, come disse anche Herzog, sono i luoghi stessi che in qualche modo te la suggeriscono, parlandoti di qualcosa?
Forse entrambe le cose. Abbiamo iniziato parlando dello Spasimo. Ecco, la storia in quel caso è nata dal luogo. Io avevo scritto tutta una parte di Fortuna, quella dell’Asl, proprio perché mi ero innamorato di un luogo di Napoli dove volevo ambientare a tutti i costi parte della storia. Ripetevo a tutti i collaboratori che non vedevo l’ora di andare a girare in quegli spazi perché avevo concepito visivamente il film proprio attorno a quegli spazi. A due settimane dall’ingresso in quegli edifici, mentre stavamo già girando, mi arriva la notizia che quella location era saltata, anche se non ne ho mai capito le motivazioni. Io sono entrato in crisi, perché tutto era partito da lì. Allora mi sono informato su chi fosse l’architetto e ci siamo messi alla ricerca di luoghi simili, riuscendo a risalire a nuove location – che sono poi gli edifici dell’Università di Monte sant’Angelo – soltanto due giorni prima dell’inizio delle riprese. Per me è stato un trauma enorme: stavo per mettermi a piangere. Come se mi avessero detto che era morto un attore.
Piccolo passo indietro. Forse, allora, a proposito della tua matrice artistica, è possibile ravvisarla proprio nell’architettura?
Sicuramente il mio sguardo si è formato più nel mondo dell’architettura, che al cinema. Penso che le persone che più mi colpiscono a livello registico sono quelle più affascinate, o comunque contaminate del mondo dell’architettura come me. Mi sono formato sulle strutture razionaliste, tra le quali, ovviamente, quelle di Le Corbusier.

Tutto, all’interno di Fortuna, “gioca” con la spazialità, i volumi, le forme. Ma ho avuto l’impressione che ti sia messo a giocare con tutto il dispositivo cinematografico nella sua totalità. A un certo punto, addirittura, più o meno a metà film, i bordi dell’inquadratura si allargano, come in Mommy. Ma mentre nel film di Dolan l’inquadratura stretta simboleggiava una realtà opprimente, e l’allargamento una sorta di auspicio, nel tuo Fortuna il procedimento è opposto, e quest’allargamento è come se rivelasse la terribile realtà occultata e mascherata in precedenza.
È la realtà che ci circonda, che ci inghiotte. È qualcosa che ha molto a che fare col mio modo di essere. Io, come tutti, ho un mio mondo interiore, e lo coltivo come fosse una scatola dentro la mia testa. Nel film non ho fatto altro che sovrapporre il mio punto di vista a quello di Fortuna/Nancy. Anzi, direi che il tentativo è proprio quello di entrare nella testa di Nancy. Allora questo formato in 4:3 mi sembrava che rispondesse a un’idea di entrare nella sua calotta cranica. In generale, tutto il film è imperniato sulla concezione per la quale l’immaginazione può salvarti dalla realtà. Di più, l’immaginazione può riscattare e dare un senso perfino alla più dolorosa delle realtà.
La storia di Fortuna, sebbene rielaborata, ha avuto un forte impatto emotivo su tutta l’Italia. E, immagino, anche e soprattutto su di te. Come ti sei approcciato a un soggetto così delicato?
Affrontare una storia del genere ti costringe in qualche modo a doverla attraversare. È stato molto doloroso, e all’inizio non volevo farlo questo film, pensavo che non si potesse proprio trattare un argomento del genere, che a livello filosofico è altamente pornografico. Man mano ho cominciato a pensare che proprio il cinema potesse essere lo strumento giusto per raccontare senza mostrare. Usando il fuoricampo avremmo potuto mettere in scena il nucleo di questo film che è il tradimento. La storia di Fortuna ha avuto un enorme impatto su di me, al punto che sento di avere questo film tatuato addosso. Mi sono mosso con le migliori intenzioni, cercando innanzitutto di comprendere perché fare questo film, e poi cercando di muovermi con estrema delicatezza affinché venisse fuori una storia edificante, che lasciasse al pubblico un monito, che lo allarmasse. Occorreva dare una funzione a Fortuna, sebbene questa sia un’operazione che io in genere non gradisco. Ma in questo caso avvertivo la necessità che l’opera avesse una funzione. Che è tutt’altra cosa rispetto alla morale. In ogni caso alla fine ce l’abbiamo fatta, e abbiamo portato Fortuna su una stella.
Nella scelta di rappresentare un luogo non chiaramente riconoscibile, mi sembra che il tuo film condivida il presupposto teorico ed estetico di diverse opere di Michael Haneke: occorre essere precisi, non locali. Ti riconosci in questa impostazione?
Storie di questo tipo sono universali. Noi abbiamo solo preso spunto dalla realtà, ma ahimè abbiamo raccontato una storia universale. Abbiamo raccontato di abusi sui minori, e questo purtroppo avviene ovunque. Far diventare universale il punto di vista di una bambina che viene tradita dagli adulti è stata letta allo stesso modo in tutto il mondo. Il film prima di uscire in Italia ha girato parecchi festival nel mondo e qualcuno lo ha anche vinto. Le reazioni sono state le stesse ovunque. La storia, evidentemente, è universale.
Nel corso della nostra intervista radiofonica mi hai detto una frase che sento di condividere parecchio: «Non sono un grande fan della realtà»: mi puoi spiegare meglio cosa intendi?
Non lo sono affatto, lo vedi anche da Fortuna, che parte da un 4:3 che racconta un po’ un’immaginazione. Per me la realtà è uno strumento, un punto di partenza. Ma non appartengo a quella categoria di registi che operano per mimesi cercando di portare la realtà tout court sul grande schermo scomparendo dietro di essa. Io mi sento più come quei registi che sono dei filtri, che si mettono tra la realtà e il pubblico e fanno da spettro. Quelli che muovono la luce in modo tale che i colori che si vedono nel prisma si sovrappongano in una definizione che decidi tu. Che non significa imporre un punto di vista, ma raccontare il proprio punto di vista. Ognuno comprende e racconta la realtà attraverso il proprio filtro. Io racconto tutto attraverso il filtro della mia mente e del mio sentire.
Leggi anche: La rivincita. Intervista a Leo Muscato: realtà archetipica e levità del racconto
Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in anteprima tutti gli articoli di Ultima Razzia!
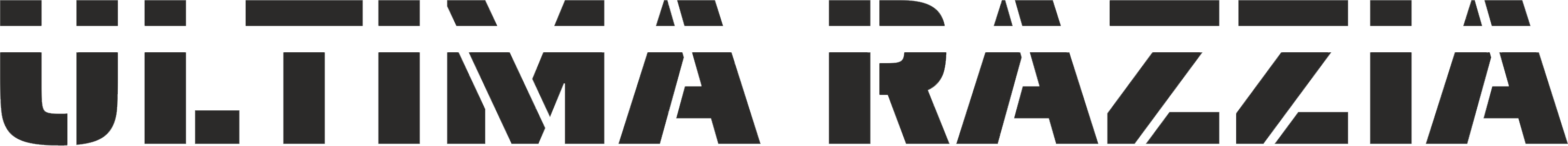



 Loading...
Loading...