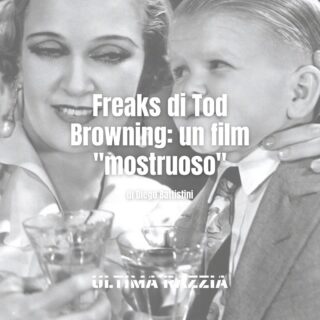La tigre bianca è il titolo del film Netflix diretto da Ramin Bahrani disponibile per gli abbonati da venerdì 22 gennaio. Adattamento dell’omonimo best-seller di Aravind Adiga, l’opera segue l’impervia scalata sociale del giovane autista Balram (Adarsh Gourav), in una parabola che lo vede emanciparsi dall’indigenza del villaggio originario di Laxmangarh fino all’imprenditoria di New Delhi.
New (B)Hollywood?
La tigre bianca è un acuto e godibile esercizio di contestazione applicato alla macro-regione indiana. Come risultato di una coproduzione internazionale dall’amplissimo respiro, la sua assimilazione al contesto bollywoodiano sarebbe solo parziale, se non impropria. Tuttavia è indubitabile che l’orizzonte culturale di riferimento sia in tutto e per tutto rappresentato da quegli standard contenutistici, esplicitamente riconoscibili e, del resto, citati in corso d’opera. Bahrani imposta il film alla luce di questo contrasto, facendone un prodotto che per temi e soluzioni si avvicina a stilemi cari alla New Hollywood. Balram è infatti un giovane emarginato a causa della sua casta di infimo rango, e la sua ascesa è sintomo di una ribellione a un sistema socio-politico – quello indiano – cinicamente descritto e talvolta persino schernito senza pietà. La sua figura e la sua parabola personificano metacinematograficamente l’intento, lo spirito dell’intero film, dotandolo di un senso che travalica lo schermo.

Il punto è solo uno: sollevare il velo di Māyā dalla “democrazia più grande al mondo” e mostrare la società indiana per quello che essa effettivamente è. Questi intenti, sbandierati abbastanza presto, diventano sempre più preponderanti man mano che il film procede, e ammantano il racconto di quell’amara verosimiglianza che stride beffardamente con la vulgata offerta spesso da Bollywood. Il popolo indiano (mi perdonino i colleghi antropologi per l’indifendibile generalizzazione) smette finalmente di essere ostaggio di melodrammi stomachevoli, lustrini, incensi, acque sacre e danze rituali.
Dalle radici vediche dell’ingiustizia fino alle metafore culinarie
Sebbene la secolarizzazione funga, oltre che da raccomandazione metodica alla visione, anche da chiave privilegiata per studiare la contemporaneità indiana dipinta da La tigre bianca, coloro i quali hanno una minima familiarità con il corpus testuale di lingua hindi non avranno difficoltà a rintracciare le radici vediche dei presupposti teorici sui quali poggia il film. Gli antichissimi testi sacri lo descrivono così: Matsyanyaya. Un concetto, questo, che rimanda all’assenza di uno stato in grado di garantire giustizia, stabilità e prosperità, e che quindi getta gli uomini in una condizione non molto diversa da quella che Thomas Hobbes fotograferà molti secoli più avanti con la celeberrima locuzione homo homini lupus.

Matsyanyaya equivale a una realtà in cui gli uomini, simili a pesci, sono costretti dalle contingenze a mangiarsi l’un l’altro pur di sopravvivere. La figura del pesce più panciuto che mangia quello più debole e denutrito non è improvvisata. Anzi, rimanda a una metafora culinaria che lo stesso protagonista de La tigre bianca ripete più volte, quando asserisce che in India esistono attualmente solo due caste: quella delle pance piccole e quella delle pance grosse.
La scorciatoia del denaro e le identità volatili
In un subcontinente che è ormai attore principale della globalizzazione, le linee di faglia sociali si evidenziano nelle pance. Tuttavia, la causa prima sta nel principale strumento atto a riempirle: il denaro. Certo, esistono ancora caste e famiglie di diverso rango, ma prestigi o sventure hanno ormai poco a che vedere con la purezza rituale hindu. Ne consegue che i segni esteriori del prestigio siano anche segni di affermazione/retrocessione identitaria. Un’identità, oggi più che mai, riconducibile alla prosaica, imprevedibile volatilità della moneta, , che compra cibo come anche rappresentanti politici. La corruzione dilagante non serve a Bahrani per denunciare l’improbabile smarrimento di sacri retaggi spirituali, ma a svelare proprio la sola scorciatoia verso il benessere che, sotto le sue spoglie, continua eternamente a poggiare sui medesimi retaggi ancestrali del Matsyanyaya: il vecchio autista che viene sostituito da Balram spera in fondo di essere un hindu, anziché un musulmano; Balram, dal canto suo, sogna di diventare ricco come il rampollo che accompagna; e questo stesso rampollo, in definitiva, sogna di essere un americano. Il gioco di scala è imperituro. A finirne fagocitati sono solo le sue pedine, quelle umane, intente a inseguire un’identità, un oltre, sempre irraggiungibile.
Seconde generazioni al bivio
Come sostiene lo smaliziato Balram, il futuro del mondo dipenderà economicamente dalla Cina e dall’India. Il processo di secolarizzazione, ormai assodato, è il classico punto di non ritorno che costringe le nuove generazioni protagoniste de La tigre bianca a misurarsi con una maggiore instabilità (sociale, religiosa, perfino castale, ma soprattutto economica) rispetto a quella esperita dai genitori. I quali, a torto, appaiono spesso essenzializzati nella loro immobile, archetipica aura di contemplativa religiosità. Questi giovani, finalmente, vengono mostrati nella loro universalità, nella loro umana e comprensibile voglia di riscatto da un mondo che per molto tempo ha patito la povertà. Non contano i mezzi, conta il risultato. Non mancano quindi neppure l’efferatezza o la violenza gratuita, ne La tigre bianca, filtrate però attraverso uno sguardo mai accusatorio ma quasi complice e ammiccante. L’imperativo è uno: «Mai essere poveri in una democrazia libera». E se per “farcela”, per liberarsi dalla stia per polli che ingabbia inconsapevoli ragazzi appartenenti alle più infime caste della società, occorre parassitare e infine vampirizzare le famiglie più abbienti, ebbene, questo fio va pagato con imperturbabile pragmatismo.

La gioventù vittima dell’arretratezza castale sembra, ne La tigre bianca, ormai consapevole che anche la libertà di scelta è una locuzione vuota, vezzo retorico che si confà ai salotti. Balram ha pienamente compreso che non c’è e non ci può essere libertà senza un certo grado di benessere. Solo chi nasce «nella luce» può davvero esercitare il diritto di arbitrio. Al di sotto delle soglie dettate da un pervadente materialismo, la libertà si tramuta in necessità e abbatte ogni moralismo salottiero. La tigre bianca, opera narrativamente e stilisticamente canonica, tenta di restituirci questa realtà. Amara, forse. Ma che trasuda autenticità.
Leggi anche: Pieces of a Woman, una traslazione del travaglio fisico sul piano spirituale
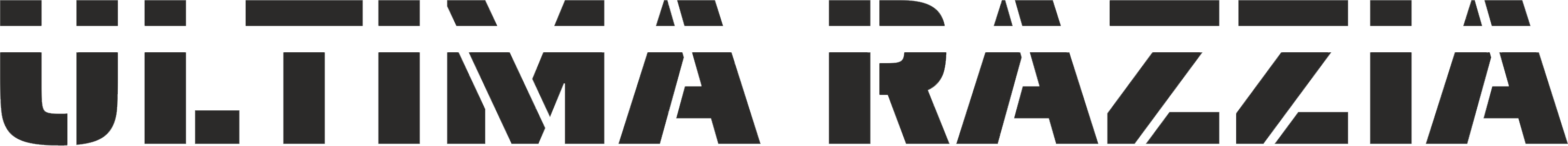



 Loading...
Loading...