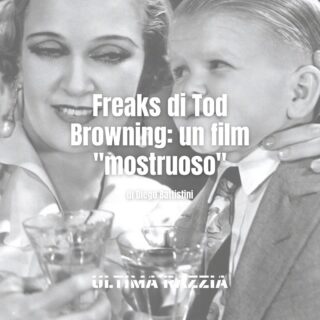Con Richard Jewell, Clint Eastwood torna a parlare di un eroismo quotidiano, reale, concreto, minuto. Il regista dagli occhi di ghiaccio continua imperterrito a battere le strade del suo personalissimo cinema-verité, fatto di storie (stra)ordinarie ed eroi qualunque, all’insegna di una decostruzione discutibile ma mai banale, irriverente e talvolta propagandistica, scarna eppure capace di sollevare ogni volta un dibattito. In una parola: eastwoodiana.
COMUNE, COME UNA BARRETTA DI SNICKERS
Gli eroi di Clint Eastwood sono persone così ordinare da correre il rischio di passare inosservate. Per bucare lo strato di questa spessa anonimia, il punto d’immersione non può che venire dal più insignificante dei dettagli, in grado di far luce per via della sua abbagliante pregnanza: una barretta di Snickers. Il comune snack, nella sua inconsueta iconicità, pare indicare un indirizzo programmatico all’interno degli ultimi lavori dell’Eastwood regista, intento a spogliare di ogni magniloquenza il discorso eroico. Le barrette sono copiose nelle scene d’apertura di Richard Jewell: nulla di più ordinario esiste di un impiegato sovrappeso come Richard, che goffamente si aggira per gli uffici rifornendo di snack i cassetti del suo capo mentre tutti lo deridono. Richard è un uomo qualunque, ma capace di notare dettagli apparentemente insignificanti, come, appunto, uno snack. Le medesime barrette di Snickers risaltano anche in una scena dal sapore intimista di Sully (2016), allorché il copilota Skiles confessa al comandante Sullenberger tutti i propri timori riguardo alla manovra di ammaraggio che li vede sotto inchiesta.

E nulla di più ordinario, ancora, potrebbe esistere di un coraggioso pilota che vacilla interiormente e che mangia nervosamente, pur sapendo di aver contribuito a salvare molte vite. Dettagli, inquadrature apparentemente ordinarie, eppure sintomatiche: l’iperrealismo di una barretta di cioccolato al centro dell’inquadratura buca lo schermo proprio perché inframmezza una narrazione limpida, una grammatica fin troppo piana e regolare, declinata con la diligente trasparenza hawksiana. Sono così gli eroi di Eastwood: individui a portata di mano, lontani da ogni retorica e talvolta ammaccati, imperfetti. Comuni, come il più comune degli snack.
QUESTIONE DI NUMERI E TEMPI
Fummo molti i detrattori di Ore 15:17 – Attacco al treno (2018), eppure la più rosselliniana delle opere di Eastwood scontava il peccato – non originale – di una scelta fuorviante dei titolisti italiani, che hanno contribuito a diffondere l’idea di un action-movie ben lontano dalle intenzioni del regista. Il più prosaico titolo americano suggerisce la subitaneità di una vicenda nella quale l’effettivo attacco al treno non rappresenta che l’addensamento finale, un tardivo e brevissimo climax. The 15:17 to Paris: tempi e luoghi fusi in una crasi indissolubile, che solo l’eccezionalità del fato rende iconiche. La scelta di Eastwood ricade di conseguenza su una radicale e a tratti impietosa decostruzione dell’eroismo, giocata quasi del tutto nella distribuzione dei tempi filmici.

Qui più che altrove, gli eroi vengono ritratti per gran parte del film come semplici, immaturi, impreparati giovanotti blandamente idealisti, con sfumature che il pubblico europeo probabilmente non esiterebbe a definire ottuse. Film come sinonimo di realtà, quindi, una realtà che per tutti (eroi compresi) è fatta di lunghi periodi di attesa, riflessioni, giorni interi impiegati nell’incertezza del domani, intrisi di azioni insignificanti. Questa, in estrema sintesi, è l’ossatura di The 15:17 to Paris, che irretisce il pubblico fino all’epifania eroica del magistrale quarto d’ora conclusivo. L’eroismo casuale, e perciò autentico, viene autenticamente reso proprio in virtù della brusca, tardiva, imprevedibile impennata finale. Sebbene il disegno deterministico di Eastwood sia talvolta ben visibile dai primi minuti, come una specie di premonizione della tesi eroica, la complessiva economia dei tempi e quel breve e concitato atto di eroismo costituiscono un chiaro tentativo mimetico nei confronti della quotidianità. La quotidianità di quei tre eroi per caso, la medesima realtà di ciascuno, che nel volgere di pochissimi minuti può improvvisamente e indifferentemente virare verso la rovina o la gloria, dotando di un senso del tutto a posteriori anche la più banale e insignificante delle precedenti azioni.
OLTRE LA PROPAGANDA
Persino in una delle opere più discusse della sua recente filmografia, American Sniper (2014), lo sguardo di Eastwood non è rimasto ingabbiato nelle strette e noiosissime maglie della disputa politica. Al di là di alcune derive propagandistiche, la riflessione sul tema della guerra si rivela più problematica e di ampio respiro. Che l’azione bellica abbia un peso relativo, è evidente dalle frequenti e brusche frenate impresse a un racconto che indugia sulla dimensione intima del soldato Kyle, sui suoi silenti sviluppi e approfondimenti psicologici. Eastwood non indugia più di tanto sulle mere gesta eroiche, bensì sul loro valore drammaticamente soggettivo. Per tutta la durata del film, Kyle pare obbedire a un antico e forse ingenuo istinto protettivo nei confronti dei deboli, rinfocolato nell’infanzia dalla figura paterna.

Coloro che si aspettano la finezza psicologia dell’erudito devono fare i conti con la poetica eastwoodiana: la magniloquenza bellica dell’impresa statunitense in Iraq, le ragioni etico-morali della guerra, sono tutti elementi di contorno quasi etnografico alla consueta destrutturazione di un eroe scisso, “costretto” a diventare tale nei pochissimi secondi a disposizione per decidere se tirare o meno il grilletto. L’approssimativo manicheismo di Kyle, infatti, svanisce non appena al centro del suo mirino si collocano i bambini, gli stessi che lui desidera visceralmente proteggere. Storie di paternità e di famiglia, di un padre assente (Kyle) che si trova a stroncare vite di figli altrui, e che non può che esitare di fronte alla cieca fatalità – tutta esistenzialistica – del caso. Compiere il proprio dovere, per il cecchino-Kyle, significa contemporaneamente aprire il varco all’assurdo, all’inguaribile contraddizione di una guerra che (lo) glorifica nel momento stesso in cui egli contravviene al moto più intimo dell’uomo-Kyle. La glorificazione verrà più avanti, ancora una volta esito imprevedibile e fortunato, mai predeterminato da una narrazione a-problematica.
UOMO VS EROE
Il dittico sulla Seconda Guerra Mondiale dedicato alla battaglia di Iwo Jima, specie nell’episodio di Flags of our fathers (2006), offre uno spunto di riflessione amaro e rabbioso, commosso e dolente, sull’eroismo. A farne le spese, questa volta, è la mitopoiesi. In un certo senso Eastwood radicalizza il suo decostruzionismo con un’opera meta-narrativa, prima ancora che meta-cinematografica. La vicenda storica, impietosamente analizzata nel suo farsi, guarda alla controversa vicenda di una fotografia assurta in brevissimo tempo a simbolo della necessità dello sforzo bellico. La cruda realtà di una sanguinante verità, occultata o semplicemente ignorata, non può però impedire alla macchinazione governativa di mettersi in moto. Eastwood mostra la spietatezza di un sistema bellico cieco e gelido, pronto a marciare anche sulle macerie nervose dei soldati, ridotti a meri vessilli o, peggio, a simulacri da esibire.

Trovando concretizzazione nel più sacro dei simboli statunitensi, ossia la bandiera a stelle e strisce, la storia trova un’ulteriore carica caustica: Eastwood colpisce dove fa più male, gettando in faccia al pubblico una verità irritante. L’Uomo – non l’eroe – viene annichilito all’interno dell’enorme industria propagandistica. E sempre l’uomo viene sacrificato sull’altare della patria predatrice: sia letteralmente (consegnando per essa il proprio sangue, i propri nervi, le proprie fibre), sia simbolicamente (i nomi e le identità dei soldati ritratti nella celeberrima foto sono a lungo oggetto di accertamento, sebbene, in fin dei conti, abbiano un peso del tutto secondario rispetto alla loro funzione). In definitiva è l’uomo, a differenza dell’eroe, che vive trincerato nei silenzi imbarazzati e nell’oscurità di inconfessabili verità, vittima sacrificale di un’universale spinta mitopoietica. Sta in questa decostruzione mitica, probabilmente, la forza universale e nient’affatto contingente della pellicola eastwoodiana: «Forse gli eroi non esistono, forse esistono solo persone come mio papà. E finalmente capii perché loro si sentivano tanto a disagio ad essere chiamati eroi: gli eroi sono una cosa che creiamo noi, una cosa di cui abbiamo bisogno. È un modo per capire ciò che è quasi incomprensibile, come alcune persone possano sacrificarsi tanto per noi, ma se mio padre e i suoi amici corsero quei rischi, e sopportarono quelle ferite, lo fecero unicamente per i loro compagni. Avranno anche combattuto per la patria, certo, ma morirono per i loro amici, per l’uomo davanti a loro, per quello al loro fianco. Se vogliamo veramente onorare questi uomini, dobbiamo ricordarli come erano realmente, così come li ricordava mio padre».
LA FUNZIONE FAMILIARE
Muovendo da figure paterne (militari in guerra, o eroi eretti a figure simboliche della nazione) ci si accorge in effetti di quanto la riflessione familiare e un certo spirito pedagogico serpeggino in gran parte dell’ultima filmografia eastwoodiana, quantomeno a partire da Un mondo perfetto (1993). È in particolare con Changeling (2008), Sully e Richard Jewell (2019) che la famiglia si configura come uno degli assi narrativi portanti, scaturendo da essa forze ad un tempo centrifughe e centripete. In tutti e tre i casi, seppur per motivi diversi, il nucleo familiare risulta in partenza monco, costretto a sfibrarsi ulteriormente nel corso della vicenda. L’assordante, scura solitudine di Christine Collins, alla quale viene rapito il figlio; l’isolamento del comandante Sullenberger, che continua a telefonare alla moglie nel mezzo dell’inchiesta che lo vede coinvolto; il più che problematico rapporto madre-figlio che condiziona pesantemente il sempliciotto Jewell. In tutti e tre i casi il medesimo nucleo, per quanto imperfetto e ulteriormente mutilato, lacerato dalle contingenze (Changeling e Richard Jewell) o dalla scelta profilmica (Sully), costituisce lo stridente controcampo di una realtà ostile e avversa, configurandosi come una dimensione alla quale tornare o, quantomeno, tendere, per riguadagnare la più autentica dimensione soggettiva e personale.

E questo non solo per un umano, banale, ovvio istinto di protezione nei confronti dei propri consanguinei. È nel raffronto con l’ennesima figura paterna della sterminata filmografia eastwoodiana, quel Walt Kowalski protagonista di Gran Torino (2008), che possiamo trovare indicazioni emblematiche di quanto detto. Al di là del pessimo rapporto con figli, nuore e nipoti, Walt troverà il proprio senso (o sarebbe meglio dire requie?) solo nella liberatoria estrinsecazione della funzione paterna negata in partenza, per di più nei confronti di un ragazzo al quale non lo vincola alcun legame di consanguineità. Sarà in quella contingenza che il suo autentico carattere verrà fuori, che la sua vera natura potrà liberarsi dalle incrostazioni caratteriali causate da un mondo ostile e violento.
LA (DE)COSTRUZIONE MEDIATICA
La piena, autentica configurazione familiare di cui sopra viene ulteriormente approfondita attraverso una solida riflessione sul potere dei media. Il terreno di indagine, costituito dal solito trittico Changeling, Sully e Richard Jewell, serve a mettere in luce una distinzione quasi heideggeriana tra la vita autentica della dimensione privata (familiare, appunto), e la realtà iper-mediatica, fittizia, tecnica, tutt’altro che autentica e, piuttosto, da costruire, validare, dimostrare. È in questa oscillazione fra le due dimensioni che i protagonisti sperimentano l’assoluta tragicità della loro condizione, costretti alla titanica impresa di rendere pubblicamente credibile l’incredibile o l’improbabile, con i media a fungere da attizzatoi. La famiglia frantumata, assediata, il cui unico rappresentante viene confinato in un istituto psichiatrico (Changeling); la famiglia lacerata da una televisione che insinua pesanti dubbi su una manovra necessaria, con i due coniugi legati dalla fredda e inautentica tecnica del filo telefonico (Sully); la famiglia disfunzionale, che ha più di qualche responsabilità nello sviluppo di un semi-disadattato (Richard Jewell). Ebbene, quella Famiglia è il medesimo locus d’elezione e manifestazione di una realtà già ovvia ai protagonisti, così come ai loro cari o ai più vicini adiuvanti; di una realtà, quindi, autentica perché “più vera”, sebbene tutta da dimostrare sul più ampio proscenio pubblico.

La sfida, a tratti titanica, è la validazione di quella verità che per larghi tratti è vissuta solo nei silenzi angosciati di un animo che sa, ma che non può (ancora) dimostrare. La decostruzione si sposta così dalla figura eroica all’intera retorica sull’eroe, una retorica che per sua natura presuppone una costruzione mediatica del discorso scandagliata da Eastwood con occhio spietato e violento. È sempre il potere dei media ad essere sotto la lente di ingrandimento, in certi casi anche in maniera volutamente grossolana e ridicola, come quando a Richard Jewell si tentano di estorcere pericolosissime dichiarazioni proprio dinnanzi ad una telecamera. Il meccanismo viene così svelato chiaramente, e la retorica memorialistica e magniloquente di Flags of our fathers, così come quella processuale di Changeling e Sully, si perde pian piano nell’insignificanza di un racconto minuto, privo di scene madri e senza alcun barocchismo, fatto di inquadrature brevi e scattanti sugli ostacoli e sulle nefandezze della quotidianità. A distanza di un secolo rispetto alle vicende raccontate in Changeling, Sully e Richard Jewell, è sempre il medesimo meccanismo a presiedere alla costruzione o alla decostruzione, basta solo mutare il punto di vista, trovarsi davantui o dietro alla telecamera. Un’oscillazione che il buon vecchio Clint conosce fin troppo bene.
Ti potrebbe interessare anche: Il cinema postmoderno di Quentin Tarantino
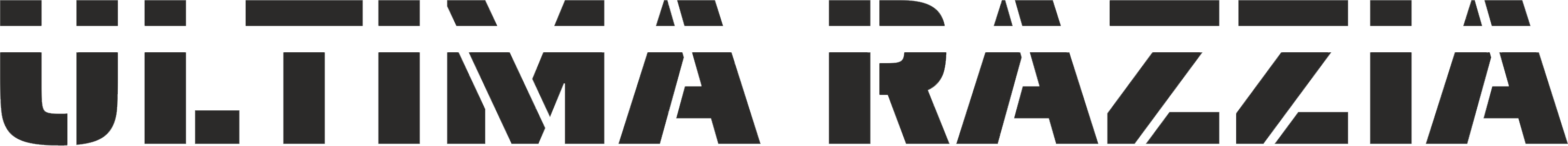

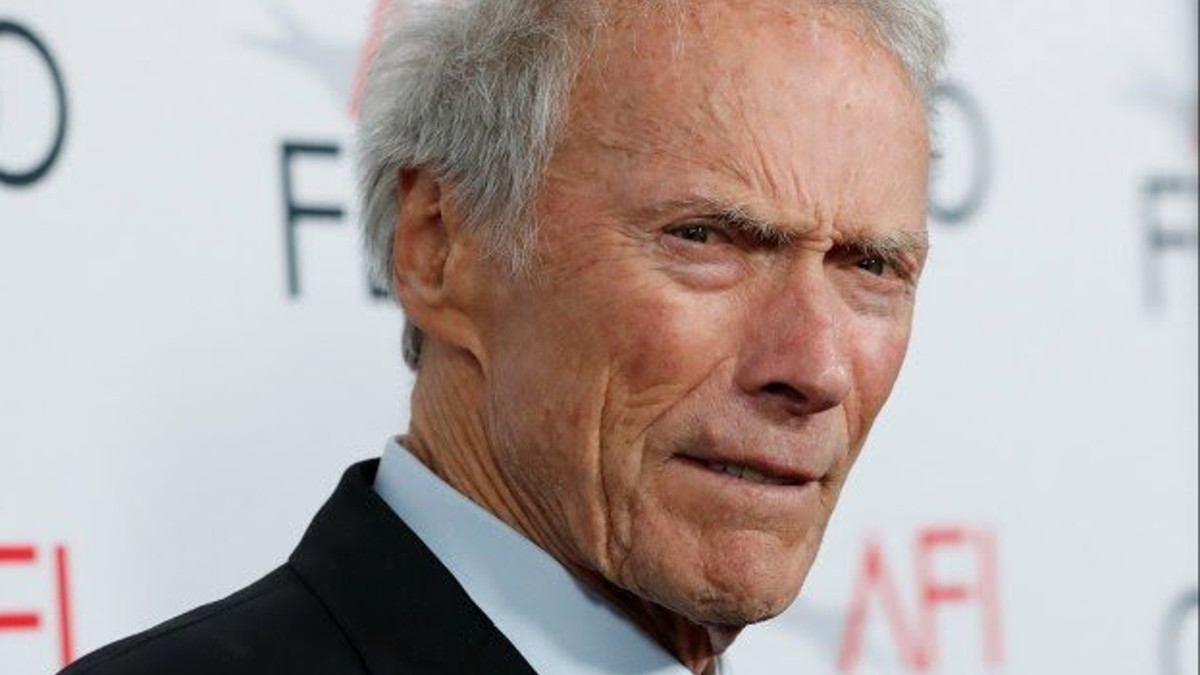

 Loading...
Loading...