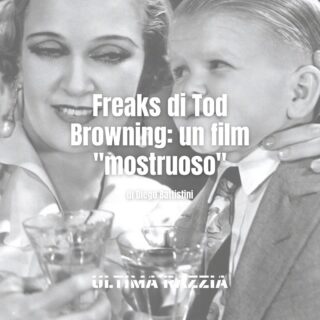La foresta di Kim
Ready? Action. Lo stile misterioso del sarcastico Gilbert Keith Chesterton trova nel racconto “All’insegna della spada spezzata” il suo apice: “Dove un uomo saggio nasconde una foglia? Nella foresta. Ma dove nasconderla se non vi è alcuna foresta? Fa crescere la foresta per nascondervi la foglia”. Ebbene, supponiamo di ritrovarci nel racconto di Chesterton e supponiamo che ciò che stiamo cercando sia proprio quel pezzo di spada rimasto incuneato tra le costole del povero maggiore Murray, da dove sarebbe opportuno iniziare? Sì, perché per certi versi, quando iniziamo a ricercare un senso profondo nel cinema di Kim Ki-duk, ci sembra di essere risospinti all’interno di una trama dal sapore chestertotiano: quello che in apparenza sembra essere il valore principale dell’arte cinematografica di Kim è in realtà la sua cifra stilistica meno importante.

Trascurabile perché, se mettiamo da parte le varie forme di puro dualismo fine a stesso disseminate nei vari film (natura vs. uomo; amore vs. odio) ci rendiamo conto di come il tema principale sia l’emergere della soggettività: cioè quello scarto che affiora dalla lotta tra l’individuo emarginato e lo “sfondo” in cui si trova ad agire. Questo cortocircuito tra “ciò che appare” e “ciò che è” in realtà costituisce il tratto caratteristico di un determinato modo di raccontare la realtà da parte di Kim.
Nel 2015 i media riportarono un avvenimento dal sapore paradossale. All’Art Basel di Miami, durante una mostra d’arte, una donna armata di taglierino accoltella un’altra spettatrice. Durante il tragico evento, gli altri visitatori rimangono impassibili in quanto convinti di presenziare ad una performance della mostra. Dunque, quello che a prima vista può sembrare un banale, sebbene drammatico, fatto di cronaca acquista una connotazione surreale. E qualcosa di analogo non è capitato a Kim durante le riprese di Dream (2008), quando la protagonista ha rischiato di morire soffocata? Dove risiede in questo caso quella qualità peculiare che rende un evento surreale?
Prendendo a prestito una connotazione concettuale dal sapore hegeliano, siamo convinti che la peculiarità del cinemascope sia di riproporre tramite immagini-in-movimento la “fatica del concetto” e pertanto ciò che seguirà sarà una disamina archeologica – intesa come metodo di recupero di reperti – in modo tale da far emergere il motivo profondo della settima arte del nostro regista sudcoreano.
L‘estetica del silenzio
Brusio di sottofondo affine ai rumori di una sala operatoria, capanno e stacco. Indugiare della camera su uno scaffale: verdura, scatolame, inquadrature fisse e stacco. L’apertura di una zip e lo scorcio di una stanza, un milieu intérieur. È l’inizio di Arirang (2011). Sembra quasi di assistere ad un parto o all’uscita di un animale dal letargo. Quello che secondo Kim Ki-duk dovrebbe rappresentare “un documentario, un film drammatico o di genere fantastico” è una pellicola sui generis: non rientra totalmente in nessuno di questi generi, ma li compenetra entrambi. Arirang (2011) è lo scarto tra di essi. Un po’ come la canzone tradizionale dal quale il film prende il titolo: non esiste una singola versione, bensì varie, così il film non può essere ridotto a nessuna delle categorie cinematografiche sopra elencate. Questo finto-documentario può apparire come il segno di una svolta, una cesura netta tra il Kim del passato e il Kim del presente. Ma se quella che sembrerebbe solo una svolta si mostrasse invece per il suo contrario? In realtà Arirang (2011) è un interludio di un percorso che vede in Coccodrillo (1996) il suo inizio, Ferro 3 – La casa vuota (2004) il suo climax e Moebius (2013) il suo epilogo.

Il silenzio iniziale, sospeso qua e là dai rumori della vita di tutti i giorni, viene definitivamente rotto dal semplice miagolare di un gatto; ed è proprio questo miagolare il primo verso emesso dal protagonista-regista in Arirang (2011). Cosicché inevitabilmente la nostra mente rievoca una delle caratteristiche preminenti del cinema di Kim: l’estetica del silenzio. Com’è magistralmente esemplificato dal passo agostiniano “tace la voce, grida il cuore”, la serie L’isola (2000), Bad Guy (2001), Ferro 3 (2004), L’arco (2005) e Moebius (2013) costituisce una pentalogia di giochi di diffidenze acustiche in cui ciò che viene non-detto è mostrato o dall’espressività del viso dei protagonisti o dal sonoro off screen o diegetico o in alcuni casi dallo strillo improvviso dei personaggi. Ciò che appare è uno smisurato scetticismo nei confronti del linguaggio umano. Il problema è che, se non posta nei termini corretti, questa insistenza sul “mutismo” dei personaggi non solo può apparire scontata dato l’utilizzo ripetuto nella serie dei film, ma può risultare frivola.
In una sequenza di Coccodrillo (1996) – opera iniziale del regista – possiamo rintracciare un “reperto” fondamentale: il protagonista, coccodrillo (è il suo nickname), dopo aver subito un pestaggio e una stomachevole tortura à la marchese De Sade, giace sconfitto e ferito sulla riva del fiume, quando ad un certo punto arriva Hyun-jung, (coprotagonista e affetta da una paradossale sindrome di Stoccolma) ad aiutarlo. La frase successiva di coccodrillo rivolta proprio a Hyun-jung, e che dovrebbe essere di ringraziamento, rivela tutta la portata simbolica dell’arte di Kim: «Puttana, stai cercando di arrivare al mio cuore». Quello che potrebbe sembrare un risibile sfogo, costituisce dunque la cartina di tornasole dell’intera pentalogia del “mutismo”, dato che il “cuore profondo” dei soggetti del regista coreano non può mai essere raggiunto tramite la lingua ma esclusivamente attraverso gli stessi eventi che compongono le trame dei lungometraggi. Difatti che cos’è il linguaggio se non un medium che ha come scopo principale quello di portare alla luce questa profondità interiore? La diffidenza nei confronti della lingua è pertanto la presa d’atto di un’impossibilità da parte dei personaggi di Kim di poter dire ciò che andrebbe detto senza scadere nell’equivocità. Sì, perché ad un esame più approfondito ci rendiamo conto che il tratto principale degli individui silenziosi che affollano l’universo cinematografico del nostro regista è quello di un’apparente impossibilità a dialogare – sono capaci, ma non parlano; come se tra l’individuo emarginato e la lingua ci fosse una barriera insormontabile. L’unica eccezione la ritroviamo in Bad Guy (2001). In una delle sequenze finali e più malinconiche del film, il protagonista, Han-gi, picchia uno dei suoi uomini per strada, ad un tratto la camera indugia in un primo piano e dalla bocca del protagonista fuoriesce una voce stridula. L’effetto è straniante e al tempo stesso comico: la tensione dei muscoli, lo sguardo minaccioso e la fronte madida di sudore contrastano nettamente con il suono ridicolo della sua voce, come se quest’ultima non fosse un prodotto della vibrazione delle corde vocali di Han-gi ma giunga da qualche altra parte (questo effetto straniante non accade anche in City Lights (1931) nella celebre scena di Charlot che inghiotte un fischietto?). La tentazione a questo punto è di pensare che se si desidera oltrepassare tale impasse rimanendo all’interno del medium linguistico il rischio che si corre è di risultare non credibili e ridicoli. Siamo quindi di fronte alla totale irrealizzabilità della comunicazione?
Il linguaggio degli oggetti
Durante il lungo monologo centrale in Arirang, Kim si lascia andare a delle considerazioni dal sapore esistenziale: «Di che cosa sto parlando? In questa baracca dove non c’è nessuno con chi sto parlando? Con chi mi sto confessando? Con nessuno. Nessuno mi sta ascoltando. La macchinetta che ho fatto io…per il caffè. Le sedie che ho fatto io. Credo che ascoltino le mie storie». Mettendo da parte il tratto squisitamente estemporaneo del discorso, possiamo notare una bizzarra contraddizione nel ragionamento: si parte dalla constatazione che nessuno ci ascolta per poi giungere alla constatazione che qualcosa ci ascolta. Dallo scoramento per lo spazio vuoto della confessione – non c’è nessuno oltre me stesso – emerge qualcosa che lo riempie – gli oggetti. Nei lungometraggi del nostro regista, le cose, gli oggetti acquistano un atipico statuto ontologico. Non delle semplici cose che ostacolano o disturbano lo scorrere delle azioni dei personaggi, bensì degli strumenti propedeutici per veicolare i significati che il semplice parlare non può trasmettere. Pertanto ecco un sfilza di oggetti: ami da pesca, palline e mazze da golf, frecce, archi, fil di ferro, banalissimi volantini pubblicitari, macchine industriali, pennelli, matite da disegno, bocce, manette, palloncini.

Questo caleidoscopico mondo oggettuale è un alfabeto fantasmagorico utilizzato dai personaggi che popolano l’universo di Kim. Se desiderano punire l’avversario ecco l’utilizzo di una mazza da golf (Ferro 3, 2004) o di un volantino (Bad Guy, 2001) o di una matita da disegno (Real fiction, 2000); se desiderano ristabilire l’ordine e la gerarchia ecco l’utilizzo di una freccia (L’arco, 2005) o di una macchina industriale (Pietà, 2012); se desiderano comunicare il loro disagio ecco l’utilizzo di un amo da pesca (L’isola, 2000) o di un palloncino (Coccodrillo, 1996). Eppure gli oggetti non possiedono un utilizzo univoco.
In una delle tante scene poeticamente sublimi tratte da Ferro 3 – La casa vuota (2004), il protagonista (un motociclista dedito ad intrufolarsi nelle case altrui) intavola uno pseudo dialogo con la coprotagonista (una donna maltrattata dal marito violento). La particolarità di questo dialogo risiede nel fatto che il medium utilizzato non è rappresentato dal linguaggio, ma piuttosto dallo scambio di una pallina da golf – un andirivieni di battute e risposte cadenzate ad un ritmo regolare dalla mazza da golf utilizzata dal personaggio principale. Quindi la mazza da golf, oltre ad essere uno strumento di offesa (in questo caso come in tanti altri Kim Ki-duk ha fatto suo e in modo quasi letterale l’adagio di Simon Weil “non c’è bisogno di un carro armato o di un aereo per uccidere un uomo. Basta un coltello da cucina”), rappresenta una chiave per poter aprire la porta dell’altro.
Sono proprio gli oggetti, quindi, i surrogati della comunicazione verbale, quest’ultima non ritenuta idonea per poter dischiudere in modo adeguato le profondità interiori dei soggetti che affollano l’umanità emarginata del nostro regista coreano.
SESSUALITA’ E UTILIZZO DEL CORPO
Si prova un certo disagio nel guardare The Birdcage Inn (1998) e Primavera, estate, autunno, inverno…e ancora primavera (2003). Pellicole profondamente diverse, eppure con un sottofondo narrativo simile: ovverosia l’impossibilità del soggetto di poter andare contro quello che a prima vista appare come un destino inflessibile. In The Birdcage Inn (1998) la coprotagonista, Hye-mi, attraverso uno sforzo titanico prova a preservare l’onorabilità della famiglia – e la sua – osteggiando la protagonista, la prostituta Jin-a, e rifiutando di avere rapporti con il suo fidanzato prima del matrimonio. I suoi sforzi sembrano premiarla, ma proprio nelle sequenze finali del film Hye-mi capitolerà concedendosi ad un avventore del motel e perdendo così la sua verginità. Anche in Primavera, estate, autunno, inverno…e ancora primavera (2003) il giovanissimo monaco buddista attraverso vari eventi e vicissitudini ritorna all’eremo per prendere il posto che era stato del suo maestro (in questo caso, a differenza di The Birdcage Inn (1998), il destino è letteralmente visibile dalla serie di porte “innestate” in luoghi aperti e richiama un modello kafkiano della realtà). In questi due film il disagio è suscitato dall’arrendevolezza, quasi gioiosa, dei protagonisti. Purtroppo il destino non può essere sovvertito, diroccato, eluso ma deve essere accolto con gaiezza. Eppure questa gaiezza lascia delle tracce.

È interessante notare che in quasi tutti i film di Kim Ki-duk la sessualità e, in modo generico, la corporeità rappresentano elementi fondamentali per poter comprendere in che modo gli individui diventano soggetti, vale a dire personaggi consapevoli del loro ruolo sullo sfondo in cui si trovano. Atti inauditi di violenza sessuale (Coccodrillo, 1996; Bad guy, 2001; The Birdcage Inn, 1998); escoriazioni e tagli superficiali (Coccodrillo, 1996; Ferro 3, 2004); cicatrici che richiamano ad un passato turbolento (Bad guy, 2001; Wild animals, 1996; Real Fiction, 2000); evirazioni e forme di cannibalismo (Moebius, 2013) amputazioni di arti (Pietà, 2012); copiose fuoriuscite di sangue che riecheggiano le mestruazioni o la rottura dell’imene (L’isola, 2000; L’arco, 2005) rispecchiano, ciascuno a suo modo, effetti di superficie di estenuanti lotte intestine. Prendiamo il macabro Moebius (2013): la raccapricciante sequenza dell’evirazione del figlio che cos’è se non un effetto di superficie della lotta spietata tra il padre e la madre all’interno dell’ambiente familiare? E in che modalità l’ordine costituito può essere ricomposto se non tentando di riconnettere i flebili fili dei rapporti tra gli individui proprio attraverso l’organo fallico, emblema del corpo ferito e martoriato?
Come sempre è in Arirang (2011) che troviamo la chiave di lettura corretta. In un dialogo surreale con la sua ombra Kim espone la sua visione della vita: «Secondo me la vita è sadismo, auto-tortura e masochismo. Si torturano gli altri, siamo torturati e torturiamo noi stessi». Hye-mi, il giovane monaco buddista ed i protagonisti dei lungometraggi del nostro regista coreano sono individui che in alcuni casi torturano gli altri o che vengono torturati, ma che in ogni caso torturano continuamente se stessi e senza pietà per poter giungere alla meta finale: diventare qualcuno, diventare soggetti.
Comunicazione non verbale, uso degli oggetti, sessualità e corporeità sono pertanto le foglie con le quali Kim Ki-duk ha creato la sua foresta; una selva di personaggi e di eventi, di violenze e di amori, di sensibilità sopraffina e di paesaggi idilliaci e il tutto scandito da inquadrature fisse e da un montaggio minimale sorrette da una densità narrativa bassa. Quella foresta è il suo luogo. È quel luogo spettacolare in cui realtà e finzione si confondono e dal quale il reale è sbucato fuori all’improvviso durante le riprese di Dream (2008). Del resto, “It’s hard to tell that the world we live in is either a reality or a dream”.
Ready? Action…
Ti potrebbe interessare anche: La trilogia cilena di Pablo Larraín e le allegorie del potere
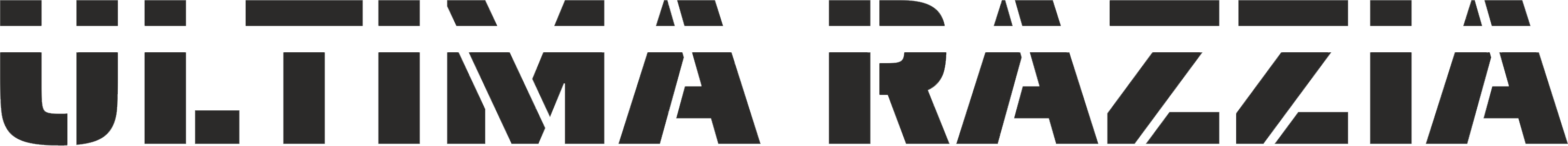



 Loading...
Loading...