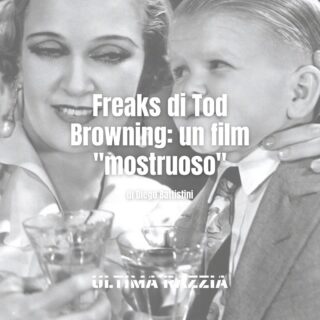Aveva ragione Grillo. In quella tranquilla sera di fine settembre del 2017 quando lo proclamò ufficialmente capo politico del M5s, dopo che aveva vinto le primarie farsa organizzate sulla piattaforma Rousseau, vincendo contro nessuno con ben 30 mila voti, il comico genovese l’aveva avvertito dal palco: “Sei il capo politico ora e sono c….i tuoi”. E lui, Luigi Di Maio, si era calato diligentemente nella parte, aveva accettato quel ruolo che più che a un segretario di partito lo faceva somigliare a un amministratore delegato di una azienda, sempre obbligato a rendere conto del proprio operato agli azionisti, e aveva accompagnato il partito, no chiedo scusa, il movimento, verso la vittoria di quelle elezioni politiche del 2018, da ricordarsi come le più scontate della storia della Repubblica. Ad ogni modo, il M5s aveva racimolato il 33% dei consensi; lui, Di Maio, probabilmente non si aspettava di fare la fine di Bersani nel 2013, ma di fatto era arrivato primo ma non aveva vinto.
È il periodo del finto corteggiamento, delle finte trattative con la Lega di Salvini, altro indiscusso vincitore politico delle elezioni: c’è molto teatro e poca sostanza in quei lunghi giorni: si mettono a punto più che altro i dettagli e la squadra di governo, probabilmente la scelta del Premier non sarà stato un passaggio facile visto l’ego di entrambi i leader, ma ai più attenti sembra, fin da prima delle elezioni, che ci si trovi di fronte a un matrimonio cui nessuno vorrà opporsi; in fondo alcune parti dei due programmi, una pare dei rispettivi elettorati hanno vissuto una strana situazione simbiotica per tutta la campagna elettorale, così come simili erano spesso apparsi certi toni usati dai due leader. Seguono 18 mesi d’amore governativo.
Lui, Di Maio, era riuscito a concentrare sulla sua (gracile) persona il quadruplice ruolo di capo politico, vicepremier, ministro del lavoro e dello sviluppo economico: in confronto il famigerato “doppio ruolo” di De Mita negli anni ’80, segretario Dc e Presidente del Consiglio, sembra una passeggiata di salute.

E però, qualcosa comincia a scricchiolare, i sondaggi cominciano a mostrare come quella impetuosa crescita che aveva caratterizzato il partito, pardon, il movimento, si attenui; lui, Di Maio, avrà pensato che tutto ciò fosse fisiologico, che fosse l’onere di governare (magari non l’avrà pensato al congiuntivo imperfetto, ma l’avrà pensato). No, la verità che lui, Di Maio, ha faticato a comprendere in quei mesi era abbastanza evidente e gli sarebbe bastato volgere lo sguardo verso il suo omologo vicepremier per vederla nella là nella sua concretezza ed efferatezza, quella verità che lo lasciava inerte di fronte a un navigato animale politico come Salvini che stava svuotando dall’interno il suo consenso elettorale, la sua leadership, la sua azione di governo e il suo programma.
Inesperienza, ingenuità ed inadeguatezza sono le componenti fondamentali della leadership del capo politico del M5s. Un politico navigato, un leader forte e carismatico, dopo aver perso come ha perso lui, Di Maio, le elezioni europee del maggio 2019, avrebbe preteso una verifica di governo, avrebbe riconosciuto il mutato clima politico e aperto a un maggior coinvolgimento del suo avversario-alleato nel governo; avrebbe addirittura potuto o dovuto alzare il livello del rischio, azzardare, richiedere che fosse Salvini ad assumere l’onere di guidare un governo ufficialmente e non più ufficiosamente: avrebbe tirato la palla nel campo degli avversari, sarebbe andato a vedere il punto ed eventualmente a scoprire il bluff, lo avrebbe costretto ad uscire allo scoperto. E invece lui, Di Maio, da ingenuo o peggio da incompetente, ha preferito continuare come se niente fosse, trincerandosi dietro espressioni degne del miglior politichese della Prima Repubblica.
Logico quindi che si arrivasse a quell’epilogo estivo, a quella crisi di governo già nell’aria da mesi.
Lui, Di Maio, avrà pensato che era ora di prepararsi a una nuova campagna elettorale, che in fondo è l’unica cosa che gli piace fare, non che sia un trascinatore di folle, ma gli piace. Avrà pensato che, essendo il capo politico del maggior partito in Parlamento, spettasse a lui una importante voce in capitolo sulle soluzioni per risolvere la crisi. Mai avrebbe pensato di essere esautorato proprio in quel momento dal suo capo, il vero capo, Beppe Grillo. La scelta di formare un governo con il Partito Democratico, la scelta di cambiare cavallo in corsa, lui, Di Maio, non l’avrebbe mai presa, vuoi per inadeguatezza politica, vuoi per coerenza programmatica.

Ma è in quel passaggio che si compie la vera fine di una leadership mai nata. E poco importa che lui, Di Maio, diventi ministro degli Esteri nel nuovo Governo Conte II; è la sua base che adesso è in subbuglio, sono i suoi gruppi parlamentari che adesso cominciano a dare segni di insofferenza, alcuni passano al gruppo misto, altri vengono espulsi dal partito, chiedo scusa dal movimento. Una leadership che non esiste, una crisi identitaria, un calo nei sondaggi e in ogni caso un governo da sostenere: è questo l’autunno del M5s.
Lui, Di Maio, si dimette da capo politico il 22 gennaio a 4 giorni dalle elezioni regionali in Emilia Romagna (dove per il M5s, che per scelta del capo politico presenta un suo candidato non avendo voluto sostenere il Presidente uscente del Pd, si preannuncia l’ennesima carneficina elettorale), dopo aver smentito seccamente le indiscrezioni uscite sulla stampa pochi giorni prima. Nel suo discorso elenca i numerosi risultati raggiunti, snocciola i successi, si inorgoglisce del percorso effettuato, annuncia che il Governo gode di piena salute e ne godrà ancora, tanto che per un attimo viene da chiedersi perché allora lui, Di Maio, si dimetta.
Ma invoca una rifondazione del partito, che non è un partito ci mancherebbe, è un movimento, e si scaglia contro non meglio precisati nemici interni, genericamente.
L’eloquio non è quello di Winston Churchill né di Aldo Moro e durante il lungo, piatto, discorso che dura quasi 1 ora praticamente non esistono picchi politici, contenutistici ed emotivi (soltanto un ridicolo siparietto finale in cui lui, Di Maio, si toglie la cravatta, ma Di Pietro che si toglieva la toga aveva ben altro spessore, ben altro simbolismo e ben altra mediaticità).

Le dimissioni preventive rispetto all’esito elettorale lasciano un M5s in preda ai suoi turbamenti. Qualunque sia l’esito elettorale in Emilia Romagna sarà in ogni caso una sconfitta della strategia di Di Maio, dal momento che se vincesse la candidata della Lega sarebbe stata indirettamente favorita dalla sua scelta di non presentarsi insieme al Pd, e al contrario se dovesse vincere Bonaccini questo dimostrerebbe ancora di più l’attuale irrilevanza del M5s e la scarsa capacità di lettura politica del suo (ex) leader.
Ad ogni modo, gli Stati Generali di marzo dovranno essere per il M5s il vero momento per guardarsi allo specchio e capire qualcosa di più sulla loro identità.
Zingaretti si augura che sia il primo passo verso la costruzione di un nuovo centrosinistra. Ma lui, Di Maio, che non è escluso possa ricandidarsi alla guida di quello che è, oggi più che mai, un partito, pare non essere dello stesso avviso.
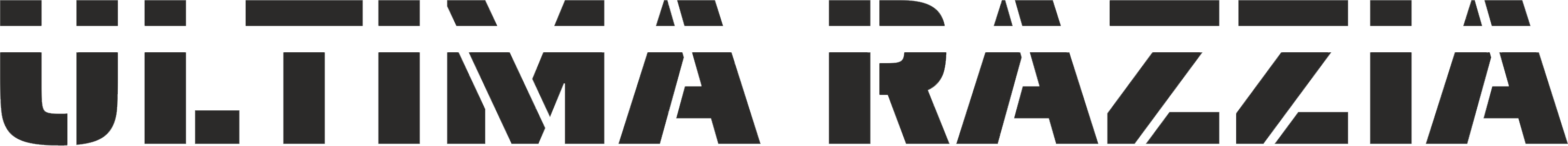



 Loading...
Loading...