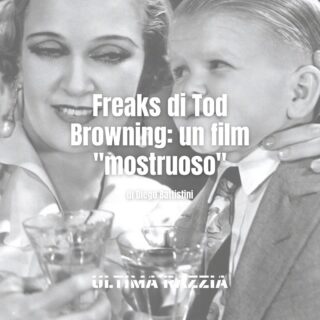“Ahlan wa Sahlan”. Benvenuta, o benvenuto. Ed è la prima espressione che ha imparato in arabo, dopo averla ascoltata, rivolta a lei da giovani, anziani, donne, bambini in ogni posto del Medio Oriente dove il suo lavoro l’ha portata. Fa un po’ sorridere leggere questo dopo aver letto oggi le ondate di indignazioni per le celebrazioni dei musulmani per la fine del Ramadan. “In 5 anni in giro per il Medio Oriente nessuno mi ha mai gridato per strada di tornarmene a casa. E non sto dicendo ovviamente che sia tutto perfetto: il problema delle minoranze etniche e religiose esiste, soprattutto in Iraq dove convivono tantissimi gruppi differenti. Le tensioni ci sono ovviamente, ma né più né meno di quello che succede in Italia con i Rom, i rifugiati e i migranti”.
Lei si chiama Francesca, e si racconta da Amman, nella bellissima Giordania, dove si trova da qualche mese come Capo Missione per una grande ONG italiana. Francesca che parla della liberazione di Mosul e dell’accoglienza delle tantissime persone in fuga dall’Isis e di un sacco di altre cose che ci auguriamo diano un po’ di fastidio a chi ha la (pessima) abitudine di fare di tutta l’erba un fascio, spazzando via i tanti, troppi, stereotipi su Medio Oriente ed Islam ai quali, ahimè, siamo stati tutti fin troppo abituati (raramente mi sono sentito accolto da qualcuno in vita mia come sono stato accolto in Palestina qualche anno fa, così per aggiungere qualcosa). Ma andiamo con ordine. Perché tra la ragazza e la cooperazione l’amore è scattato forse per caso. Se qualcuno ha voglia di credere al caso.
Il “debito di nascita”
Nel 2011 la guerra civile in Libia era appena finita, e quella in Siria stava per cominciare. Francesca è in Nord Europa, per tutto un altro genere di lavoro. “Grazie ad un’amica, sposata con un libico di seconda generazione, entrai in contatto con dei rifugiati libici arrivati in Europa per cure mediche. Attraverso i loro racconti, e quelli dei rifugiati siriani che arrivarono subito dopo, mi feci un’idea più verosimile del conflitto che stava infiammando il Medio Oriente e soprattutto dei suoi effetti devastanti, sulle persone e sulle cose”. La prima partenza è come volontaria con una piccola organizzazione locale che operava al confine turco-siriano, nella provincia turca di Hatay. In quel momento è cambiato tutto. “L’esperienza in Turchia ha cambiato la prospettiva di molte cose, facendo crescere un senso di responsabilità verso quelle persone, decisi che volevo in qualche modo iniziare a fare la mia parte”. Si chiama “debito di nascita”, quello che si dice appartenga a tutti quelli nati dalla parte “giusta” del mondo. “Sia ben chiaro non giudico chi sceglie altre strade, ognuno è libero di saldarlo a modo suo, o anche di non saldarlo affatto, ma per me, trovarmi così vicino alla devastazione della guerra, è stato un punto di non ritorno: avevo capito cosa volevo fare della mia vita. Ripensando a quel periodo, mi rendo conto di aver corso anche io dei rischi, e forse sono solo stata più fortunata di Silvia. Ma la cosa che trovo importante oggi è che, molto probabilmente, senza quell’esperienza di volontariato, oggi non sarei qui dove sono ora”.

La notte prima del Kurdistan Iracheno
Come spesso accade, le aspettative prima di ogni partenza non rispecchiano mai la realtà che attende di essere vissuta all’arrivo. “Ricordo che, la notte precedente alla prima partenza per il Kurdistan Iracheno non riuscii a dormire, un misto di eccitazione e curiosità per ciò che mi aspettava lì, ma anche preoccupazione e forse un po’ di paura”. Francesca era diretta ad Erbil, città sicura anche se a un passo dalla linea del fronte e ai territori occupati dallo Stato Islamico. L’organizzazione con cui la ragazza era partita era una di quelle solide, con un piano di evacuazione ben predisposto e delle chiare procedure di sicurezza. “Il capo progetto che si trovava in loco, aveva sedato tutti i miei dubbi durante il briefing prepartenza fatto via skype, ribadendo più volte che la situazione era assolutamente sicura, ma non mi sentivo comunque tranquilla”. Il perché è presto detto. In un Paese in guerra è tutto in guerra? “Non riuscivo a credere che una zona del paese venisse bombardata ogni giorno, e che a soli 80 km la vita scorresse come nulla fosse. Ma era proprio cosi ad Erbil e lo capii dopo pochi giorni il mio arrivo, quando iniziai ad integrarmi nella comunità di espatriati, a partecipare alle feste organizzate il fine settimana, ad andare al cinema, in palestra, a fare shopping nei centri commerciali all’occidentale, o a mangiare cibo vietnamita nel ristorante sotto casa”.
Mosul libera
All’entrata della città c’era un cartello, uno di quelli che si vede all’ingresso di ogni agglomerato urbano del pianeta. Solo che in questo caso c’era scritto, più o meno, “Benvenuti a Mosul, capitale dello Stato Islamico”. E’ stata una delle prime cose sparite dopo la liberazione dall’Isis. Francesca ha vissuto, praticamente “in prima fila” uno degli avvenimenti più importanti della Storia di questi ultimi anni. “Mosul libera e fine dei combattimenti: probabilmente il momento più bello. La regione era ancora totalmente instabile, e tanto era ancora il lavoro da fare”. L’80% della parte antica della città di Mosul era distrutta, tantissimi profughi si erano diretti ad Erbil negli ultimi mesi quando i combattimenti si erano fatti più intensi, rendendo così i campi di accoglienza molto più che affollati, “ben oltre la loro capacità e tendopoli improvvisate erano spuntate come funghi in diversi angoli della citta. Mancavano i servizi primari, le condizioni igieniche erano precarie e c’ era il rischio del diffondersi di epidemie. Non c’era sufficiente acqua potabile, mancava il cibo e le medicine, le donne non avevano latte per i loro neonati, il numero di morti e feriti gravi era al di sopra di ogni previsione. La situazione era assolutamente drammatica, ma la buona notizia era sapere che finalmente si poteva ricominciare”.

“Vedevo la paura nei visi stravolti dalla fatica e la mia spariva”
Non è un discorso di voler apparire come un’eroina né tantomeno come un’incosciente. “Non voglio passare né per una né per l’altra: credo però di non aver mai avuto veramente paura, sai quella che ti blocca. E’ stata una mia libera scelta quella di andare a lavorare in una zona di guerra, e se avessi avuto paura avrei potuto tranquillamente tirarmi indietro. Sapevo anche di non essere indispensabile, e che se non ci fossi stata io qualcun altro l’avrebbe fatto, ma c’ero io insieme ai miei colleghi, ed ero felice di essere li”. Un’emozione, una sensazione, che sta tutta nel vivere e nell’agire quotidiano. “Guardavo negli occhi le donne, gli uomini e i bambini a cui distribuivamo cibo e acqua, alcuni di loro non bevevano acqua potabile e non mangiavano nulla da giorni. Gente che dopo aver perso tutto, aveva camminato per chilometri sotto il sole, scappando dalle bombe, evitando di pestare mine e di finire sotto il tiro dei cecchini, vedevo la paura nei visi stravolti dalla fatica e la mia spariva. Come potevo aver paura dei colpi di mortaio che sentivo cadere a qualche km di distanza, quando avevo di fronte persone che quei colpi se li erano visti cadere sulla testa. Persone alle quali quei colpi avevano portato via la casa, un familiare o una gamba o un braccio”. Chiaramente ogni missione fa storia a sé. “Al momento mi trovo ad Amman in Giordania, che è un po la Svizzera del Medio Oriente. Un paese stabile, moderno e in generale con un alto livello di sicurezza. Tuttavia, la situazione per i rifugiati ma anche per le fasce più basse della popolazione locale è difficile anche qui, soprattutto a causa dell’impatto della crisi Siriana che nel corso degli ultimi 9 anni ha devastato l’economia locale e il mercato del lavoro”.
La tutela nelle Ong e le zone a rischio
Assicurazione, copertura delle spese mediche ed eventuali spese di rimpatrio. Nulla è stato lasciato al caso nelle organizzazioni per le quali Francesca ha lavorato in questi anni. “Avevano un piano di evacuazione e solidi procedure di sicurezza, preparati da un dipartimento specifico all’interno dell’organizzazione chiamato Safety and Security che si occupava di fare si che tali protocolli fossero sempre aggiornati e seguiti da tutto lo staff. Ricevevamo regolari training di Primo Soccorso e di preparazione a lavorare in zone di conflitti armati”. Non mancavano, durante questi training, le simulazioni di rapimento da parte di un gruppo terroristico. “Naturalmente tra la simulazione e la pratica c’e una differenza enorme, ma senza dubbio sono state delle nozioni estremamente utili che per fortuna sono rimaste sempre solo teoriche e non mi sono mai servite”. E’ particolarmente interessante la spiegazione delle missioni nelle zone “calde”. “Quando era necessario recarsi in alcune zone a rischio, come per esempio le aree appena liberate dalla presenza dell’Isis, ci venivano fatti indossare giubbotti antiproiettile ed eravamo in costante contatto radio con la sede centrale che a sua volta aveva contatti con le forze di sicurezza, cosi da sapere in anticipo l’evolversi della situazione sulla linea del fronte ed eventualmente indietreggiare”. Alcune missioni vengono annullate proprio all’ultimo momento, proprio perché la situazione in quei teatri, instabile per definizione, era cambiata improvvisamente.

La “banalità” dell’accoglienza
Gli stereotipi tutti occidentali sul Medio Oriente vengono spazzati via da Francesca con un sorriso. “Credo che il Middle East sia una una tra le zone più ospitali al mondo, soprattutto verso gli stranieri. Probabilmente ciò deriva anche da retaggi culturali, fatto sta che io mi sono sempre sentita ben accetta e trattata come un ospite di riguardo, se non direttamente come un membro della famiglia”. Questo ovviamente non vuol dire che non esistono persone poco gradevoli, se non sgradevoli. “Ci sono ovviamente anche qui, e ne ho anche incontrate, ma la maggior parte sono state generose e ospitali”. Un semplicissimo discorso di dare e avere. “Sembrerà banale, ma anche quelle che avevano ben poco da offrire, lo dividevano con gioia e dignità, mettendomi quasi a disagio”. E tutto questo senza dimenticare quello che questi popoli passano giornalmente. “E nonostante questo, dimostravano di avere una resilienza incredibile, cosa che raramente mi è capitato di vedere in Occidente”.
La nostra quarantena come il rapimento di Silvia Romano?
In molti hanno paragonato la nostra quarantena ai 18 (diciotto) mesi di rapimento di Silvia Romano. Un paragone impensabile anche solo a dirsi, ma che per molti è verosimile. “E’ una delle cose più stupide che abbia mai sentito. Essere costretti, con le dovute virgolette del caso, a rimanere a casa per un mese o due, sapendo che è un sacrificio che va fatto per arrivare ad un bene comune, sapendo che puoi fare un’autocertificazione e al massimo te la cavi con una multa, avendo a disposizione l’abbonamento a Netflix e il frigorifero pieno di cibo, la connessione ad internet, il corso di yoga on line, le videochiamate con gli amici, l’appuntamento alle 6 per cantare con i vicini sul balcone (almeno all’inizio), è evidentemente ben diverso dall’essere rapita in Kenya da uomini armati di machete, senza neanche riuscire a capire cosa ti stanno dicendo, senza sapere se verrai uccisa, magari dopo essere stata stuprata o torturata”. Passare 18 mesi in cattività, essere spostata di nascondiglio in nascondiglio, senza poter neanche fare una chiamata a tua madre per dirle che stai bene, aggiungendo alla preoccupazione che hai per la tua sorte, il pensiero del dolore che sta provando la tua famiglia, e tutto ciò senza sapere quando e se li rivedrai ancora. Questa è stata la “quarantena” subita da Silvia. “Io credo che nessuno di noi possa capire cosa ha passato Silvia e tutti quelli che come lei hanno vissuto un rapimento”.

Pandemia e guerra
E’ possibile paragonare quello che abbiamo vissuto a un conflitto? Lo abbiamo chiesto a chi la guerra l’ha vista da vicino. “Credo sia irrispettoso anche paragonare la pandemia ad una guerra. La metafora della guerra, dove il Covid-19 è il nemico, i medici sono eroi, i morti sono caduti e quelli che si sono salvati sono i sopravvissuti, l’ho sentita rimbalzare più volte, sia tra esponenti politici che semplici cittadini, ma lo trovo quanto di più inappropriato ci sia per descrivere l’emergenza dovuta al Coronavirus”. Il perché è presto detto. “Per quanto la situazione sia stata drammatica, soprattutto nel nostro paese, quelli che parlano di guerra è perché la guerra vera non l’hanno mai vista. Allora il mio invito a questa gente è che, se non hanno interesse nel chiedere ai rifugiati che abbiamo in Italia che cosa significa sopravvivere alla guerra, se è simile o meno ad un periodo di quarantena, allora chiedano almeno ai propri nonni che la guerra l’hanno vissuta e subita”.
Saremo tutti più buoni dopo?
Il ritorno in patria di Silvia Romano è stato scintilla per mostrare il peggio di molte persone. Il quadro emerso è impietoso. “Credo che molta gente sia ignorante, profondamente frustrata e infelice della propria vita. La pandemia e la quarantena hanno esasperato ancora di piu queste situazioni e invece di far emergere il lato buono, come molti speravano, hanno liberato il lato gretto e meschino di molti”. Una facile equazione: quando sei frustrato e infelice con te stesso, la cosa che sopporti di meno è la felicità altrui. “Penso che Silvia quando è scesa da quell’aereo fosse troppo felice e questo non è andato giu ai molti che l’hanno attaccata. Il fatto che abbia dichiarato di essersi convertita ha incrementato ancora di più quell’odio latente, ma anche se non l’avesse fatto, sono sicura che le reazioni verso di lei non sarebbe state molto più umane. Basta ricordare come furono trattate Greta e Vanessa al loro ritorno pur non essendosi convertite, tanto per citare un caso”.

“Mi sento in dovere di difenderla”
L’esperienza da cooperante di Francesca è oggi una professione qualificata e ben retribuita, che ha visto e vede studi quotidiani per una necessaria crescita professionale, vista la complessità del compito da portare avanti. “Silvia è all’inizio del percorso che io e molti miei colleghi abbiamo fatto. Quindi, pur riconoscendo le immense differenze tra un volontario e un cooperante, differenze che la maggior parte della gente invece ignora, devo dire che si, mi sono sentita attaccata quando hanno attaccato lei ed è anche per questo che mi sento in dovere di difenderla. A differenza di quello che molti le hanno detto, io spero che Silvia si riprenda presto e non abbandoni il volontariato e la cooperazione, io spero che riparta se ne ha voglia e non abbandoni il suo sogno perché è di persone come Silvia quello di cui abbiamo bisogno, nella cooperazione e più in generale nel mondo”.
“Non sono Madre Teresa”
Francesca ci chiede di restare anonima. “Non perché temo le critiche o i commenti negativi della gente frustrata di cui sopra, ma perché temo di più gli eventuali commenti strappalacrime di chi mi farebbe passare per la nuova Madre Teresa. Solo le persone più vicine a me sanno qual è il mio lavoro, non mi piace parlarne per non essere fraintesa, e questa credo sia la prima volta che lo racconto cosi dettagliatamente”. Due le reazioni che Francesca ha incontrato quando è successo di dover raccontare più o meno nei particolari il suo lavoro. Entrambe spiacevoli. “Da un lato la critica del – ma chi te lo fa fare, puoi fare <<volontariato>> in Italia, sei pazza! – dall’altra l’adorazione di chi mi vedeva come una sorta di eroina, dal cuore grande. Non mi sento di far parte di nessuna delle due categorie. Faccio quello in cui credo e vengo pagata bene per farlo. Ho numerosi colleghi da tante parti del mondo che fanno il mio stesso lavoro in altrettante parti del mondo, per noi non è affatto qualcosa di eccezionale, ma la normalità ormai. Sono fortunata: faccio un lavoro che mi appassiona e che mi ha arricchito interiormente, esperienza dopo esperienza”.
Un lavoro che ti conduce nei posti dai quali la gente fugge. Non è eroismo, è semplicemente la consapevolezza di esserci e di fare qualcosa per gli altri. Nel caso di Francesca, ascoltare i racconti di una donna che aveva visto uccidere il marito dall’Isis, portare acqua e cibo a chi aveva superato chilometri, sabbia, mine e bombe per trovare la salvezza dentro una tendopoli, un campo profughi come un’oasi dopo l’inferno superato. Quando ci riuscivano. E ancora bambini che hanno visto le loro case crollare sotto le bombe. Questo è essere una cooperante. Ed essere riusciti ad ascoltare l’esperienza di chi ha veramente vissuto certe esperienze aggiunge la stessa consapevolezza anche in noi. E magari farò riflettere chi continua a parlare senza conoscere. E senza pietà.
Ti potrebbe interessare anche: Storie di cooperazione che unisce: Andrea, il Kenya e la banalità dell’ipocrisia
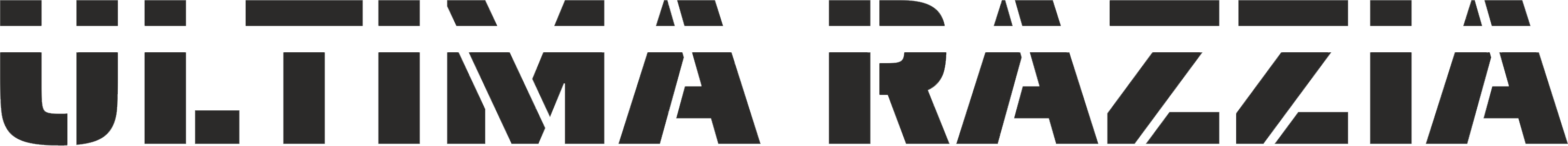



 Loading...
Loading...