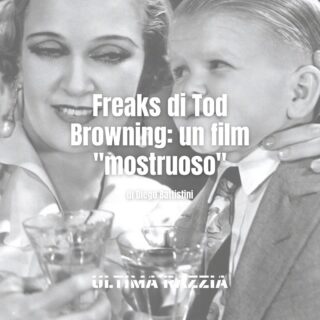Europa, diretto da Lars von Trier, rappresentò più di un film. Acme del formalismo “terapeutico” del regista, fu il capitolo conclusivo della trilogia europea. E fu anche un film dopo il quale nulla fu più come prima.
Europa-aporuE
L’Europa degli spettatori. Europa di von Trier. È in questa rimozione dell’articolo determinativo, quasi impercettibile ma essenziale, che si colloca (non tanto casualmente) la portata del film. Europa non serve tanto a determinare una realtà storica, che pure si respira. Non dispensa giudizi, né dipinge affreschi sociali. Il concetto vontrieriano di Europa non precisa quasi nulla, ma sfuma, intreccia, accumula e annaspa. Per citare Ghezzi, è un film palindromo. In questo, rivela tutto il suo artificio, le sue ascendenze kafkiane.

Palindromo è del resto anche il suo anno d’uscita, il 1991: quattro caratteri che si possono leggere in un verso o nell’altro, un po’ come il film che parla di sé e d’altro, in un infinito gioco di rimandi. Una costruzione, questa, che serve anche da traccia ermeneutica. Europa. 1991. Capitolo finale di una trilogia, quindi segmento ultimo di un triangolo che si chiude in se stesso. Il costante andirivieni emotivo, concettuale, stilistico e talvolta metatestuale. Europa è un tragitto psichico ed emotivo. È una delle tante declinazioni (degli eccessi talvolta cervellotici) di Lars von Trier, che a quel 1991 arriva portando sulle spalle un groviglio di problematiche personali ineluttabili, e quindi – almeno per lui – necessariamente formalizzabili. Per lui il film non è mai solo un film.
Un cumulo di problemi
Lars è già “von” dal 1977, quando, ancora giovane membro dell’associazione di registi amatoriali Filmgrupp 16, antepone l’iconica particella al Trier familiare. Un po’ accidente auto-biografico sfruttato ad arte, un po’ specchio di debordante personalità, è così che firma il suo primo mediometraggio, Orchidégartneren (1977). Per la parte del protagonista affetto da personalità multiple – che egli stesso interpreta – guarda al trasformismo dell’idolatrato David Bowie. Si riallaccia agli stilemi mesmerici delle opere di Marguerite Duras (India song, 1975), cita Fellini per rafforzare la tesi artatamente metacinematografica sottesa all’opera e popola il racconto di nazisti, ebrei ammalati e relazioni lesbiche e sadomaso. Nel 1979 è la volta di Menthe – La bienheureuse, anch’esso di una stucchevole artificiosità narrativa e allusivo a sessualità complicate e talvolta violente, con evidenti sconfinamenti nella blasfemia e accenni alle retroproiezioni di Europa.

C’è poi il mediometraggio di diploma alla Danske Filmskole, che conclude il suo burrascosissimo percorso accademico fatto di molteplici provocazioni nei riguardi dei suoi professori. È il più tarkovskijano dei suoi lavori giovanili, Befrielsesbilleder (“Immagini di una liberazione”, 1982). Il formalismo è però esasperante, la narrazione labirintica, i piani temporali ai imiti della comprensibilità, così come gli eventi narrati. E di nuovo, immancabile, ecco un sanissimo istinto provocatore, nella scelta di rappresentare i tormenti amorosi di un nazista per una donna in un paese che pare venga liberato dall’occupazione nazista: «Considerare la capitolazione da un punto di vista tedesco era una cosa piuttosto provocatoria per un danese», dice. L’opera – claudicante a dir poco – rivela al pari delle altre una ricercatezza così estrema da risultare, alla fine, insostenibile. Malagevole almeno quanto il mastodontico storyboard disegnato per l’occasione dall’amico scenografo Tom Elling, fido collaboratore a venire.

Secondo l’accademico e amico Peter Schepelern, von Trier concepì Europa «per essere un capolavoro». Come tale, quindi, non avrebbe potuto non recare le stimmate della concezione carnale del cinema di von Trier. Questo film (come sempre, del resto) avrebbe dovuto inscenare – e quindi, in qualche modo, risolvere – alcuni degli intimi disagi di un giovanissimo regista cresciuto nell’assoluta assenza di limitazioni, costretto a far contemporaneamente da genitore e da figlio, auto-imponendosi regole che contemporaneamente bramava di infrangere. Da un lato sdoppiandosi, avendo in mente più voci nella sua testa come i protagonisti dei suoi primi lavori. Dall’altro, anche, disciplinandosi e affrontando l’enormità dei problemi produttivi e post-produttivi di un’intera trilogia. Il cinema, per lui, era un’esperienza realmente totalizzante, che equivaleva anche ad affrontare le paure da ipocondriaco; le ossessioni per la drammaturgia; le dissonanze emotive e le perversioni.

Tutto ribolliva in quel brodo primordiale, e fino alla conclusione della sua prima trilogia si concretizzò spessissimo in acque sporche, immagini scurissime e sgranate, onnipresenti voci off e over, sovrimpressioni, dissolvenze. Un caos, spesso affastellato e indistinto. Il trittico europeo si concretizzò come acme di un lungo percorso “terapeutico”. Se tutti i film precedenti erano fatti di narrazioni ondivaghe e incerte, di imperscrutabili intrecci e di realtà ai limiti della consistenza, di livelli sovrapposti, era chiaro che la loro regia era lo specchio di un’intricatissima fluidità interiore che si metteva in scena. E che, quasi da sola, germogliava in un tentativo forse non del tutto conscio di rintracciare una soluzione, una fine. Una cura, magari. Ma come non c’è arrivo senza tragitto, come non c’è cura senza diagnosi. Probabilmente è giusto porla proprio in termini vagamente medici, la questione. Europa. 1991. Palindromo. Dal testo all’autore e ritorno. Forse non è un caso che nell’intera trilogia l’auto-analisi abbia un discreto peso.
Reductio ad unum: ingresso transmediale nel regno delle tenebre
Riaffermando il suo approccio quasi carnale e dionisiaco al cinema, nel 1990 von Trier aveva redatto uno dei suoi celebri manifesti, affermando in maiuscolo: «IO, LARS VON TRIER, NON SONO CHE UN SEMPLICE MASTURBATORE DELLO SCHERMO». La pre-produzione di Europa non differisce in nulla da quella dei precedenti lavori: la sua sete interiore viene lasciata libera di attingere da un’oceanica vastità di spunti, suggestioni, citazioni. Tutte agiscono come pulsioni. A corredo c’è anche da aggiungere che per la prima volta il regista ha a disposizione un budget enorme racimolato con enormi sforzi, e sofisticatissime attrezzature da impiegare. Non c’è granché di strutturato nel soggetto. Persino considerare Europa come premeditata conclusione dell’altrettanto premeditata trilogia europea, insieme con L’elemento del crimine (1984) ed Epidemic (1987), equivarrebbe a travisare il moto primo del metodo vontrieriano. Il quale è sempre caoticamente in fieri, istintivo e ribelle, agli esordi; e solo dopo viene medicalmente controllato e razionalizzato dall’ossessione tecnica.

Dalle “E” iniziali dei tre titoli internazionali viene così fuori – a posteriori – l’iconica idea della E-trilogy, e precisamente all’interno del pressbook di Epidemic, grazie all’intervento dello sceneggiatore Niels Vørsel, vero e proprio maniaco dei simboli. Ci sono poi l’idea del treno, che pare provenga da un libro danese per bambini intitolato Toget, dove il tema del viaggio e del sogno sono indissolubilmente legati. Non mancano i riferimenti variamente cinefili: La signora di Shanghai (1947) dell’amato Welles; La morte corre sul fiume (1955) di Charles Laughton (omaggiato nell’immagine del protagonista Leopold che, una volta annegato, fluttua come Shelley Winters); qualche inquadratura dal sapore hitchcockiano e dalla scenografia vertiginosamente sacrale del Nostalghia (1983) di Tarkovskij, in occasione del matrimonio di Leopold e Katharina.

Tra masturbazione e possibilità fino a quel momento inusitate, Lars von Trier si trova a dover dipingere su una tela dai confini enormi e con una tavolozza cromatica esageratamente generosa di soluzioni. Resta da trovare un fil rouge che leghi Europa ai due precedenti film: «Era molto importante che la trilogia fosse composta da film che non erano molto simili. Avrebbero dovuto avere qualcosa in comune, ma nulla di immediatamente riconoscibile. Questi film raccontano quasi la stessa storia, quella di un idealista che viaggia sperando di salvare la gente e tutto va storto». Non solo: occorre dare coerenza interna – almeno dal punto di vista narrativo – al film. L’ipnosi arriva quasi come (ovvia) epifania: «Credo senz’altro nell’ipnosi. E credo che guardare film, in larga misura, sia una specie di auto-suggestione. Nessuno crede realmente che qualcosa stia succedendo sullo schermo. Nulla accade davvero finché non incontri il pubblico. È anche per questo che mi interessa il noir. Ha sempre avuto un effetto ipnotico su di me. Specialmente quelli di Welles». L’utopia iniziale del duo von Treir/ Vørsel sarebbe addirittura quella di ipnotizzare il pubblico una volta entrato in sala, ma il progetto viene abbandonato per conservare solo lo spunto narrativo del topos ipnotico, già battuto sia ne L’elemento del crimine che in Epidemic.

Poi c’è la storia personale di von Trier. Il quale ha spesso sostenuto di essersi identificato con il suo protagonista, Leopold Kessler. Colta in questa intersezione, l’ipnosi diventa forse ben più di un semplice spunto narrativo. In quella costellazione di immagini, suggestioni, citazioni e frammenti che fluttua nella testa del regista, occorre congiungere i puntini, che come le stelle in un cielo oscuro devono essere collegate come le stazioni ferroviarie della Germania. L’ipnosi diventa quindi anche un tramite: tra von Trier e il suo personaggio, e tra questi due e il pubblico. Stiamo tutti insieme, su quei binari che nella splendida carrellata fantasma aprono il film. Non potremmo andare da nessun’altra parte. Nulla viene tolto al retrogusto vagamente medico e scientifico della pratica ipnotica, nella parabola personale del regista. Semmai, molto vi viene aggiunto, per accumulo. La voce di Max von Sydow scandisce un conto alla rovescia inesorabile, su quelle rotaie che somigliano tanto – forse troppo: un’altra citazione, stavolta del montaggio ėjzenštejniano? – alla sagoma della pellicola cinematografica.

Cinema come viaggio (possibilità) e come terapia (limite). Al contempo, cinema come direzione ostinata e obbligata, per von Trier, che ama descriversi come un solitario che letteralmente si obbliga sulla sua propria via. Anche a dispetto del dolore fisico. Ecco, von Trier si sta incatenando, su quel treno. È, quel treno. E lo siamo anche noi. Pronti, finalmente, a entrare nel cuore più oscuro d’Europa/Europa.
L’ossessione tecnica come prova disciplinare
L’autodisciplina terapeutica di von Trier però non deve essere solo a livello teorico e concettuale, ma anche di tipo operativo e pratico. È quanto emerge già in fase di produzione. Il film viene infatti realizzato sulla base di un imprescindibile «postulato tecnico»: filmare la scenografia indipendentemente dalle riprese degli attori. La prima parte delle riprese, quella dedicata agli esterni, viene realizzata nel 1989 tra la natia Danimarca e la Polonia, un paese in piena transizione democratica dopo la catastrofe comunista. Ma già il lavoro preparatorio di von Trier e dello scenografo Henning Bahs raggiunge impressionanti abissi di meticolosità sartoriale. Lo storyboard è a dir poco mastodontico: circa 800 schizzi totali, frutto di due anni di lavoro e almeno cinque versioni differenti. Ecco la prima terapia d’urto. Non può esserci spazio per alcuna improvvisazione: tutto, ma proprio tutto è (già stato) pianificato, e deve essere realizzato esattamente come da programma.

Una difficoltà non secondaria, dato che tutte le scene polacche sono realizzate in notturna dal direttore della fotografia Edward Klosinsky, mentre von Trier resta quasi sempre seppellito nella sua roulotte. La sua incrollabile fiducia nel maniacale lavoro svolto in preparazione gli permette di arrivare spesso poco prima del ciak, giusto per controllare che tutto sia stato posizionato esattamente come previsto (comprese le armi illegalmente introdotte e i manichini in latex da appendere ai lampioni: i werwolf). Non male per un masturbatore compulsivo, che dimostra di tenere benissimo a bada la sua irrefrenabile libido. Forse l’esperienza negli squallidi e fatiscenti hotel polacchi dell’epoca sarebbe bastata a raffreddare anche gli entusiasmi di un toro da monta, costretto, pur di mangiare, a farsi spedire del cibo in scatola dalla Danimarca.

Ma nemmeno la seconda parte delle riprese realizzata in presenza degli attori negli studi danesi può lasciare il minio spazio all’incertezza o all’improvvisazione. I movimenti degli interpreti, infatti, sono stati anch’essi del tutto incasellati nello storyboard, quindi devono combaciare alla perfezione con le retroproiezioni realizzate in Polonia. Con Jean-Marc Barr la sintonia è immediata, giacchè egli non si dimostra affatto recalcitrante all’esigenza di lavorare per sottrazione: «Una delle idee di base era che il protagonista non facesse niente, o se non altro il meno possibile e, un po’ come un personaggio di Hitchcock, fosse semplicemente destinato a guidare lo spettatore durante il film». Diverso è il caso della complessa, quasi ferina personalità di Barbara Sukowa. E naturalmente di Ernst-Hugo Järegård. Viziatissimo, insopportabile e capriccioso, Järegård assilla tutta la troupe con richieste assurde anche al di fuori del set, ragion per cui von Trier decide di ricattarlo: a fine giornata, se si sarà comportato diligentemente, gli verrà allungato un sigaro cubano Davidoff.

Nulla è lasciato al caso. Tutto è CONTROLLO. Persino nella cattedrale polacca di Chojna, dove von Trier e la produzione danese si servono dell’esercito russo per illuminare la scena attraverso i riflettori anti-aerei. Quella stessa armata, che aveva quasi ridotto a un cumulo di macerie quella stessa chiesa nella Seconda guerra mondiale, viene anch’essa ridotta (controllata) al rango di un qualsiasi operatore di scena a disposizione del demiurgo.
Il nazismo e l’ebraismo sono questioni personali
Per un regista che ha fatto della tecnica la propria ossessione, è quasi un punto d’orgoglio rivendicare la propria originalità. Ai molti che hanno ravvisato nelle distorsioni figurative, nei giochi chiaroscurali e nelle retroproiezioni di Europa un richiamo all’espressionismo, von Trier ha chiarito: «Abbiamo distorto un po’ le cose, è vero. Ma non è affatto quello che chiamerei un film espressionista». Le mirabilie della macchina da presa e le frequentissime carrellate, unite ai pochissimi, calibratissimi ma eloquenti elementi profilmici “colorati” (narrativamente/emotivamente pieni di pathos) servono a ribadire l’artificiosità esasperata di una pellicola che non teme di addentrarsi con veemenza e magniloquenza, quasi con sfrontata possanza in una delle più grandi ferite della storia europea. Una ferita che è anche, per inciso, una delle ossessioni di von Trier: il nazismo. Vale la pena di ricordare che la faccenda è ricorrente in tutta la filmografia vontrieriana, corti e mediometraggi compresi. Non solo: von Trier è addirittura convinto che nelle sue vene scorra sangue ebraico, da parte di padre. Una menzogna, questa, alimentata da sua madre fin sul letto di morte, nel 1990. È in quei dolorosi momenti che la verità viene a galla: non solo non possiede nemmeno un millilitro di sangue ebreo, ma il suo padre biologico non è colui il quale ha creduto fino a quel momento.

L’ossessione poetica diventa dramma personale. E di nuovo, la storia filmica si intreccia con quella intima: troppo, per non portare il dramma dell’Olocausto all’interno di quel processo di auto-analisi che è Europa. «Forse ora è diverso, ma ai miei tempi la Germania era vista come uno stato canaglia. L’abbiamo sentito un sacco di volte. Anche altri stati lo erano, ma l’intera storia era raccontata unicamente da quel punto di vista. Dopo abbiamo cominciato a vederla da un’altra prospettiva.La Germania era il punto d’incontro tra me e Niels (Vørsel). Lui era più fissato di me con la Germania. Suo fratello viveva a Colonia e gli interessava tutto ciò che fosse tedesco. Era affascinato e disgustato al tempo stesso. Io ero affascinato dalla Seconda guerra mondiale. O meglio, ero interessato. La Germania è sempre sembrata pericolosa. Per chi ha viaggiato poco come me, la Germania è il mondo. Lì si è veramente lontani da casa». Ecco spiegato il peso sempre più concreto che la Germania assume all’interno di Europa. Diversamente, in L’elemento del crimine, Europa e Germania sono concetti più simbolici, quasi mistici e musicali, mai apertamente citati (non a caso, nel secondo capitolo della trilogia, i nomi delle città hanno solo un “suono tedesco”, ma non abbiamo mai precise indicazioni delle località dove l’azione ha luogo).
Peccato mortale
Lars/Leopold sono come pesci dentro la rete su quel treno che viaggia nel cuore oscuro dell’Europa. Hanno il cuore greve, sono combattuti. All’interno del più recondito degli anfratti d’Europa, nella carne martoriata di un continente ancora sanguinolento e lacerato, il giovane Kessler è scisso tra il suo amore e il suo dovere, tra i collaborazionisti e le forze alleate. Il giovane von Trier non è da meno, scisso tra mille fuochi: l’urticante impeto provocatorio, la ricercatezza tecnica, la smania di emergere, di affermarsi. E noi siamo lì con loro, che – non senza un pizzico di orrorifica ironia – li guardiamo muoversi tra un capo e l’altro del convoglio emotivo, prima che fisico. Ma si sa: von Trier è uno che adora trovarsi (o mettersi) in simili ambasce, a differenza del suo protagonista. È un parafiliaco delle difficoltà, delle limitazioni: poco importa che siano autoimposte o etero-imposte, come accade nell’illuminante e spesso snobbato Le cinque variazioni (2003). Non per niente, parlando di questo controverso aspetto del proprio mestiere, cita Tarkovskij, sostenendo di apprezzare maggiormente quei lavori realizzati sotto la dittatura sovietica. Cita anche Dostoevskij, che pressato dall’imminente consegna si dava alla scrittura frenetica dell’ultimo minuto. Secondo von Trier, per fare della sana arte, «sembra che tu debba avere una catena attorno al collo di qualche tipo».

E di catene simboliche ed emotive von Trier è saturo. Giunge – potremmo dire finalmente – al cuore del più spinoso dei periodi storici del Vecchio Continente con la necessità di fermarsi a pensare. A razionalizzare. A controllare. Quindi a rispondere, se necessario anche con quel cinismo che è prodromico all’apollinea imperturbabilità e freddezza di colui il quale, ormai, sente di aver esaurito il proprio compito. Controllare il film è come giungere a un personale percorso di maturazione. Una specie di tappa emotiva È infatti lo stesso von Trier a definire Europa come il suo film più freddo e ragionato, controllato, appunto. Il caos concettuale e manieristico, la fluidità dei lavori iniziali, cede quindi il passo alla più franca, pragmatica delle asserzioni al cuore del film: «Dio non potrà mai perdonare il miscredente, l’ignavo, l’incapace di schierarsi per una causa. Costui sarà condannato da Dio a errare in eterno. Non riceverà misericordia, signor Kessler. E poiché non sei né tiepido, né caldo, né freddo, io ti sputerò fuori dalla mia bocca», con tanto di citazione dell’Apocalisse 3,16.

Se Leopold Kessler, nel tentativo di «essere gentile con la Germania», finisce col perire, non è perchè ha scelto la parte sbagliata con la quale schierarsi: perisce proprio perché non ha scelto. Fino ai suoi ultimi istanti lo vediamo rimbalzare tra il suo esame con i funzionari della compagnia ferroviaria e i suoi piani sovversivi. Il fato (la giustizia?), alla fine, toglie sempre il tempo e la vita: occorre scegliere, prima che sia tardi. È con la morte dell’ignavo che il film si conclude. Ed è con la dissoluzione del Lars-controllore dittatoriale del film che von Trier, algido, si congeda da una parte quintessenziale della sua multiforme personalità. Per sé stesso, anzitutto. «Non ho mai fatto film con l’intento di educare la gente. Anzi, proprio l’opposto. Europa ha cambiato solo il mio stile cinematografico, perchè era la logica conclusione del metodo del controllo, per quanto mi riguardava. Non c’era proprio alcun posto dove andare, da lì. Già The Kingdom (1994) ha una struttura molto più blanda, come già lo stesso Epidemic. Non riesco a vedere come avremmo potuto continuare sulla strada che avevamo tracciato, specie dopo L’elemento del crimine e Europa. Non era proprio possibile: si era esaurita. Sono soddisfatto di alcune cose della trilogia, ma non di altre. I dialoghi, ad esempio, sono stilizzati in modo intollerabile. Se mi diverto a vederli? Non li guardo proprio!».

Europa. 1991. Un film non necessario. Non schierato. Non pedagogico. Non storico. Troppo «patinato», per piacere al von Trier adulto. Eppure c’è ancora qualcosa di magnetico che ci spinge a guardarlo, ad ammirarlo, a scovarne dettagli semi-nascosti. Ma da non prendere troppo sul serio, nemmeno se in gioco c’è dello spicciolo esistenzialismo applicato all’orrore nazista, a milioni di morti, a uno sterminio di massa. Come lo descriverebbe von Trier? Così: «Un film fottutamente mitologico!»
Leggi anche: Melancholia e il (distruttivo) simbolismo del femminile
Iscriviti al nostro canale Telegram per ricevere in anteprima tutti gli articoli di Ultima Razzia!
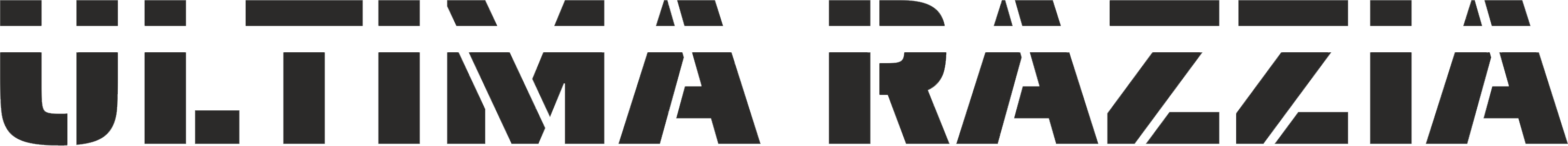



 Loading...
Loading...